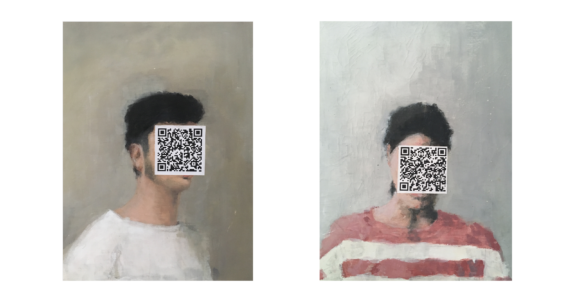In mezzo a quel “teatro instabile” che è Venezia, la britannica Sarah Staton arriva con una mostra dal titolo semplice e spavaldo: Abbiamo Stoffa curata dalla giovane Yasmine Helou, alle Fondamenta dei Penini
Non è solo il titolo che gioca con la parola “stoffa”, ovvero talento, materia, carattere ma un programma, quasi una sfida. Staton mette davvero in scena stoffe, tele, denim, vetri, e ci fa inciampare. La sua è la prima personale a Venezia, ma non ha nulla di timido o di introduttivo: è piuttosto un colpo di forbici sul tessuto della città.
Uno dei lavori centrali, Laguna (2025), sembra in apparenza un telo di jeans scolorito. Non colori aggiunti, ma sottratti. Non pittura, ma anti-pittura. Il denim non è lì come moda ma come storia: il “sergé de Nîmes” francese, la Genova dei blu per le vele, l’America dei jeans. Tutto compresso in un rettangolo che diventa insieme mappa e manifesto, tessuto industriale e ricordo artigiano.
E se ci pensi, non è forse questo il destino di Venezia? Essere luogo di transito, di commercio, di mescolanza, di appropriazione. Staton non dipinge sopra la laguna, la scolora. Toglie colore come se stesse sbiadendo un souvenir troppo a lungo lasciato al sole. E in questo gesto minimo, quasi domestico, riesce a dire molto di più su turismo, globalizzazione e memoria di quanto possano fare interi saggi accademici.
Poi ci sono i cocktail. Non quelli che si bevono in Piazza San Marco a quindici euro al bicchiere, ma quelli costruiti in legno lucido, pieni di minuscole creature di vetro. Sembrano giocattoli, sembrano bomboniere, sembrano regali da duty free. Ma messi lì, in serie, diventano metafore. Del turismo di massa, della serialità del consumo, del locale trasformato in globale e riconfezionato in confezioni brillanti.
È ironico e allegro, certo, ma anche amaro. Perché tu ridi davanti a un margarita pieno di animaletti di vetro, e poi ti rendi conto che è la fotografia perfetta di un mondo che beve tutto ciò che incontra, senza distinguere più i sapori.

E poi ci sono i dots. I puntini metodici, ordinati, cuciti o dipinti su tela. E qui entra in scena il fantasma di Damien Hirst e dei suoi famosi “spot paintings”. Hirst li ha moltiplicati all’infinito, fino a svuotarli di senso. Staton li riprende, ma li riempie di nuovo. I suoi punti non sono piatti, non sono riproducibili all’infinito come un catalogo Ikea: sono materia, tessuto, corpo.
In un certo senso, Staton ridà peso a ciò che era diventato leggero, restituisce corpo a ciò che il mercato aveva trasformato in segno sterile. Il punto, in fondo, è anche zero nell’alfabeto arabo, origine e possibilità infinita. Qui diventa nodo, tessitura, piccolo universo che non si lascia appiattire.
Uno degli aspetti più intriganti della mostra è come Staton metta in dialogo opere vecchie e nuove. Ci sono lavori del 2007 e 2008 accostati a quelli del 2025. Non è nostalgia, ma autocritica, confronto, aggiornamento. È come se dicesse: “Ecco, questo ero io allora, questo sono io adesso. Il mondo è cambiato, anch’io, ma certi fili continuano a tirare.”
E il filo, letteralmente, è quello del tessuto, della stoffa che unisce i pezzi. Dai jeans scoloriti ai puntini cuciti, dalle tele glitterate ai cocktail con creaturine di vetro, tutto si tiene.

Venezia come specchio
Non poteva esserci luogo migliore di Venezia per questa mostra. Perché Venezia è sempre stata il laboratorio perfetto per l’arte come commercio, per il passaggio da tavola a tela, per la trasformazione della pittura in merce scambiabile. È città di contrasti, di eccessi, di estetica che sfiora l’indigestione. Truman Capote lo aveva detto bene: “Venezia è come mangiare una scatola intera di cioccolatini al liquore in una sola volta.” Staton sembra raccogliere questa frase e rilanciarla, con il sorriso ironico di chi sa che non puoi davvero resistere a quei cioccolatini.
Alla fine, Abbiamo Stoffa non è una mostra che ti schiaccia con la teoria o che ti respinge con la freddezza concettuale. È piuttosto un gioco serio, un invito a ridere e pensare allo stesso tempo. Le opere sembrano leggere, colorate, persino decorative. Ma dentro c’è un discorso feroce sulla gentrificazione culturale, sull’industrializzazione della creatività, sul destino stesso delle città che diventano marchi registrati.
Staton non punta il dito, non predica. Sorride, gioca, scolora. Ti mette davanti un cocktail di vetro e un jeans scolorito e dice: “Ecco, questo è il mondo, che ti piaccia o no.” E tu, in qualche modo, ti ritrovi a riconoscerlo.