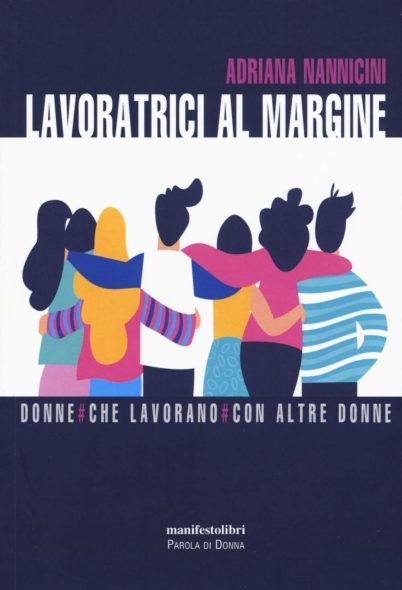“Lavoratrici al margine. Donne che lavorano con altre donne” di Adriana Nannicini, il lavoro come motore della rappresentazione di sé
“Lavoratrici al margine. Donne che lavorano con altre donne” di Adriana Nannicini, il lavoro come motore della rappresentazione di sé
‘Lavoro’ e ‘donne’ sono due universi di senso per cui ci si chiede, a tratti, se debba effettivamente ancora esistere una questione oppure se la questione esista in seno al lavoro stesso.
Quanto parliamo ancora di istanze produttive, improduttive, di leva per la piena cittadinanza, quando parliamo di genere oggi? Dopo la cosiddetta seconda ondata femminista degli anni ’70 in cui il paradigma emancipazionista aveva reso il tema dell’inserimento femminile nel mondo del lavoro centrale ai fini delle rivendicazioni politiche, abbiamo assistito ad un ampliamento dei fronti di interesse del femminismo che progressivamente si è inoltrato più sul versante dei diritti riproduttivi e sessuali.
Cosa resta di quell’afflato paritario che aveva spinto le mobilitazioni di allora verso l’ingresso massiccio delle donne nel mondo del lavoro? Cosa resta delle battaglie sul riconoscimento del lavoro domestico? Cosa resta del lavoro …..?
Il testo di Adriana Nannicini “Lavoratrici al margine. Donne che lavorano con altre donne” (pp. 108, 2019, Manifestolibri) attesta la necessità e il desiderio di riprendere le fila di quel discorso e lo fa soprattutto parlando la lingua dei case-studies, dei dati empirici discorsivi e relazionali, della ricerca qualitativa che scompagina la logica della produzione di risultati a favore di nuove domande, nuove ricerche di senso.
Il breve volume dona analisi accattivanti non solo sulla femminilizzazione del lavoro nel postfordismo (tema già trattato da Nannicini nel suo “Le parole per farlo. Donne e lavoro nel postfordismo”, 2002), bensì indaga alla radice cosa sia percepito oggi come lavoro da donne che lavorano in diversi settori e che spesso lavorano con/per altre donne: centri per l’impiego, cooperazione internazionale, immigrate badanti in Italia. È un atto di sorellanza, è un atto di disvelamento di ciò che rende il lavoro oggi una dimensione dell’umanità. Parte dalle donne e va molto oltre, non si ferma alla dicotomia lavoro remunerato vs. lavoro non remunerato. Come ben osserva Simona Bonsignori nella sua Introduzione “Donna, insomma, deve diventare una declinazione politica” (cit. Simona Bonsignori, p 12).
Gli obiettivi del testo puntano a svelare, dunque, la cancellazione del lavoro delle donne – in casa e fuori casa, svelare le comunanze tra lavoratrici ‘manuali’ e ‘intellettuali’ – ovvero le molestie, come ben descritto dall’inchiesta della giornalista Stefania Prandi sulle braccianti nel Mediterraneo (Oro Rosso 2018, vincitrice del premio giornalistico Otto Brenner Preis per l’inchiesta giornalistica Rape in the fields); svelare il desiderio e il bisogno di riconoscimento delle donne, da ricevere e da dare (p. 101). Il lavoro si imprime prepotentemente sulla scena nel complesso significato di interazione fra individuo e ambiente, di modificazione del contesto sociale; ma, soprattutto, il lavoro viene alla ribalta come motore della rappresentazione di sé in un’epoca in cui si scivola facilmente nel decretarne la morte felice.
Cosa costituisce ‘lavoro’ oggi senza essere nominato? Nannicini non affronta il lavoro femminile in chiave quote rosa o di parità di genere, seppure analizza i casi in cui la neutralità delle nostre istituzioni e delle agenzie per il lavoro prefigurano la necessità di ricorrere a queste misure come unico strumento per rendere visibile una disparità che penalizza donne e uomini. Il patriarcato non è morto, insomma, e le donne che hanno detto il doppio sì alla famiglia e al lavoro non vivono ancora pienamente queste due dimensioni che restano forgiate dalla prospettiva maschile, a differenza di ciò che si è decretato con un po’ di ansia celebrativa in “Immagina che il lavoro” (Sottosopra – Libreria delle Donne di Milano, Marzo 2009).
Lo spunto interessante che viene suggerito da Adriana Nannicini è di non sessualizzare quel ‘lavoro d’amore’ (p. 39) che concerne il tempo di vita, quel lavoro di relazioni e accudimento che divora ogni spazio per sé, per farsi belle (p. 32), proprio perché non condiviso e reso indivisibile dalla figura femminile (moglie, madre, sorella, fidanzata, amante, escort, psicologa, etc ..). Scindere questo tipo di attività, di affezione, dall’essere donna resta una questione anche per chi offre dei servizi a pagamento, a mio parere, dato che ciò non scalfisce la disparità di genere ancora vigente in quei settori e la pericolosità insita nel lavorare con i sentimenti, il corpo, e le relazioni (vedi l’uccisione della psichiatra Paola Labriola a Bari nel 2013).
E, allora, la scommessa è davvero remunerare il lavoro domestico di cura? Cosa si può etichettare come altruismo…? Cosa perdiamo nella logica esclusiva dei diritti e dei doveri? “Lavoratrici al margine” rimarca l’importanza di immaginare altro per evitare l’esclusività femminile nella gestione degli affetti e del tempo di vita. Ma senza negare all’esperienza quotidiana il ruolo prezioso rivestito dal ‘fare disinteressato’, dalla pratica di amarsi fra altri e con se stesse perché è di questo che siamo fatte e fatti.
L’autrice ritorna a ‘le parole per farlo’ e racconta della necessità di intessere una collettività prima di inquadrare la questione del ‘lavoro’. E lo fa esplorando il significato di questa parola tra sforzo, processo, prodotto, attività umana. Lo fa ascoltando donne migranti che fanno un lavoro in Italia che non esiste nel loro paese, oppure altre per cui il lavoro ha subito già nel loro paese una progressiva svalutazione semantica. Vale la pena riportarne alcuni stralci:
• Iuliana, ucraina: “domo xazaika, una donna di casa, una che lavora in casa, una casalinga … in casa propria e in casa d’altri la parola è la stessa, può essere la donna che aiuta e allora è druc hata, un’amica di casa; non ci si rivolge a lei come a una badante, ma come a un’amica che viene ad aiutare: anche se questo è molto raro da noi. ‘Badante’ lo usiamo tutte senza tradurre, non è necessario, abbiamo imparato cosa vuol dire … per noi è una parola un poco offensiva che cerchiamo di non usare, indica una persona di basso livello, ci fa sentire che siamo donne di un paese povero e che abbiamo lasciato i nostri figli” (pp. 31-32)
• Liuba e Lina, ucraine: “da noi non ci sono lavori come badante, sono le figlie che si occupano dei genitori anziani, se con ci sono, delle altre donne di famiglia e ci sono persone esterne, non c’è una parola come questa che serve ad indicare un lavoro che si fa qui, da noi non si può dire pomogain pogliam liudiam, una persona per aiutare gli anziani” (p. 32)
• Seguir luchando, lottare per il lavoro. Irsa Milagros, cubana, a proposito del significato di lucha (lotta): mentre “il popolo cubano era stretto come un eroe tra l’embargo nordamericano e il sistema; mostrava le battaglie da vincere con la perseveranza degli ideali, oggi invece indica il lavoro, pian piano si è sminuito, si è trasformato nell’andare a cercare denaro, con mezzi leciti e meno leciti, ogni mezzo serve per il sostentamento. Luchar era anche fare il parrucchiere in casa all’epoca in cui il lavoro privato non era permesso … anche le ragazze, le jeneteras stavano luchando, ma erano chiamate con un termine comunque spregiativo, se non volevi usare parole più crude. Forse quella parola è usata perché ha anche a che fare con un cavallo, quindi una qualche allusione sessuale nel cavalcare” (pp. 35-36)
La materialità del lavoro sembra essere scomparsa dalle analisi più accreditate finendo per rendere invisibile il lavoro stesso, e il lavoro delle donne. Nannicini si chiede come mai non riusciamo più a produrre un immaginario potente sul lavoro come all’inizio del secolo scorso in cui la fotografia e il cinema hanno reso immortali le icone sullo sfruttamento del lavoro nel modello fordista. Come mai non vediamo di più il lavoro, il lavoro manuale delle donne con bracciali e anelli, il più faticoso e assegnato a loro, come ritratto da Salgado nella costruzione del canale del Rajasthan (p. 91)? Perché riusciamo di più a pensarlo che a immaginarlo?
Uno degli aspetti più espliciti e controcorrente del testo è quello relativo alla richiesta di armonia e ricchezza vita/lavoro anche per chi non è madre. Le interviste portate avanti dall’autrice nei centri per l’impiego o con cooperanti mettono in luce il bisogno di legami e di socialità fra donne che vivono la stessa condizione di precarietà, di lavoro e di affetti. Molto interessante la discussione sul fare rete, tra colleghe, connazionali, utenti di un servizio di formazione, per rientrare nel mondo del lavoro, per passarsi informazioni, per stabilire contatto (p. 44). La paura di specchiarsi nell’utente donna (p. 46) da parte di una operatrice di un centro per l’inserimento professionale rende bene l’idea dell’angoscia esistenziale della precarietà, in cui svolgere il tuo lavoro significa costantemente avere di fronte l’immagine di chi potresti diventare quando fra un anno ti scadrà il contratto. Oppure diventerai madre.
Infine, una potente critica alla narrazione dominante sull’emigrazione dall’Italia, dove cervelli E braccia sono in fuga e i dati vengono letti sempre parzialmente quando si tratta di esaminare i tassi di emigrazione dal Nord o dal Sud Italia verso l’estero (p. 63). Chi arriva nel nostro paese dal Sud del mondo è un migrante, chi, come le cooperanti, viaggiano in direzione contraria sono definiti expat. Nannicini discute attentamente la storicità del fenomeno della cooperazione dagli anni ’70 in poi, da quando cioè si partiva per ideali politici e sempre più si è passati a tecnicizzare perdendo quasi totalmente la visione d’insieme del lavoro interculturale. Dove non si tratta di implementare freddamente programmi di welfare o industriali ma anche di confrontarsi con un ambiente in cui l’impronta white e western offusca lo sguardo di chi non sempre tiene in adeguata considerazione il sistema di privilegi di cui usufruisce (pp. 78-79). Solitudine, molto spesso, in cambio di reddito e di riconoscimento che in patria non verrebbero garantiti:
“Per la vita che facevo a Milano io mai e poi mai avrei fatto un figlio… invece venendo qui ho iniziato a pensarci ma perché no? Forse in realtà sarebbe possibile… un po’ le condizioni logistiche qui sono molto più facili, perché hai a chi lasciare il figlio, se si ammala c’è la babysitter, c’è quella che fa le pulizie”. (p. 81)
La precarietà in patria non è diversa da quella planetaria, ricorda efficacemente l’autrice, laddove la competitività su scala globale non apporta maggiore sicurezza contrattuale – anche nella cooperazione – ma soprattutto moltiplica le forme di isolamento sociale e incertezza affettiva.
Il lavoro vivo, dunque, si annida nelle migrazioni e si solidifica nella difficoltà di restare aggiornate quando si vive in determinate zone del mondo, nelle molestie, nella mancanza di benessere psicologico. Il lavoro vivo, dei corpi in movimento, non è morto. Può solo morire nella mancanza di socializzazione.