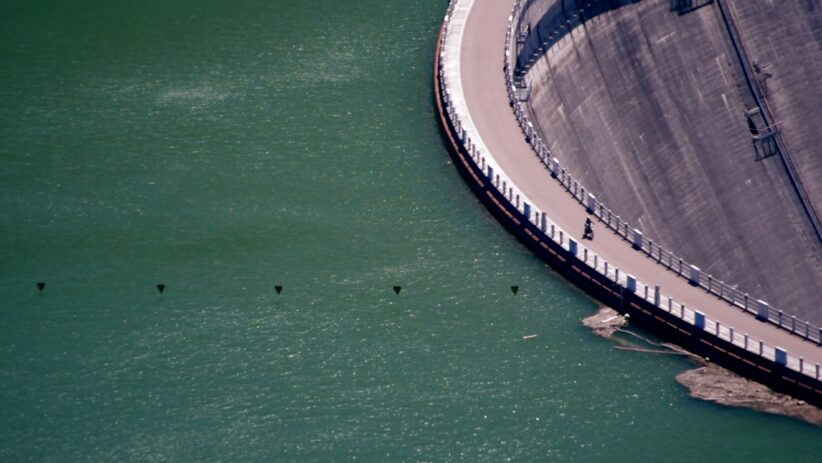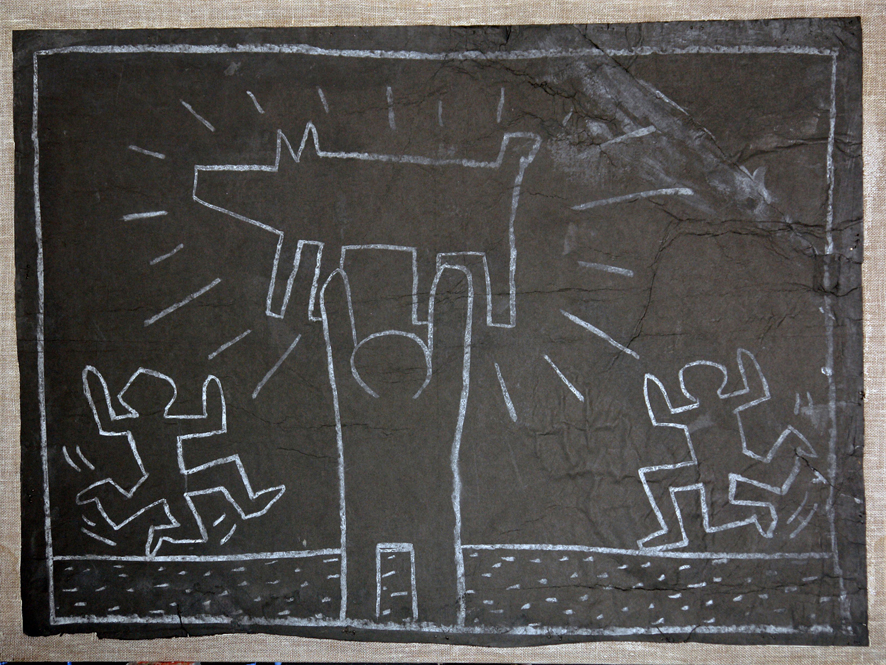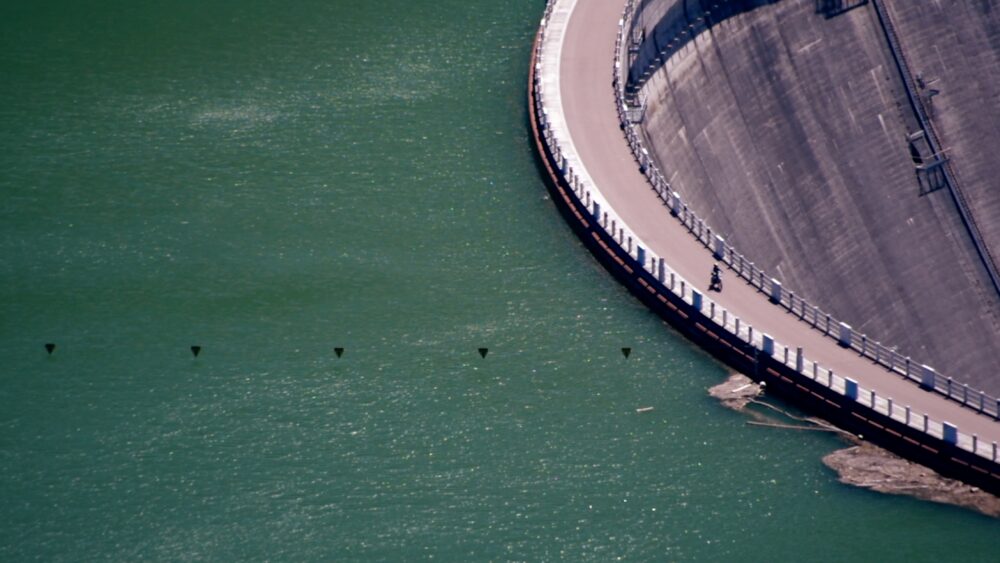
Caterina Erica Shanta è nata nel 1986 in Germania; artista e regista, è vincitrice, assieme a Liryc Dela Cruz, del Torino Social Impact Art Award – premio del bando indetto da Artissima e Torino Social Impact – grazie al progetto Talking About Visibility.
Per l’occasione abbiamo dialogato con lei approfondendo la sua estetica e il suo lavoro.
Sono rimasto molto colpito dalle colonne sonore scelte per i tuoi film. Volevo chiederti come selezioni la soundtrack di un tuo lavoro, è qualcosa di creato insieme a un compositore o fa parte di un lavoro di ricerca che poi adatti al film? Che ruolo ha la colonna sonora all’interno dell’opera?
Innanzitutto, grazie mille per questa intervista. Posso dire che nel caso della produzione video concepisco il suono quasi come un secondo film sovrapposto alle immagini in movimento, esso restituisce un livello di complessità narrativa ulteriore o un terzo spazio extradiegetico.
Lavoro spesso con un compositore per ragionare assieme sul paesaggio sonoro registrato, per processarlo, campionarlo e reinserirlo nel film. La musica talvolta sottolinea un focus, una punteggiatura o una sospensione temporale nella mente dello spettatore. È un linguaggio che scandisce il tempo e restituisce vibrazioni nello spazio, lo riempie e avvolge i corpi.
In alcuni miei video la musica riveste un ruolo predominante, ad esempio ne La Tempesta (2019) dove essa deve riempire l’intero spazio espositivo e premere sullo spettatore. In A History About Silence (2018) la musica entra brevemente un paio di volte in mezzo al silenzio per spazializzare le immagini, fa danzare gli elementi nebulosi tra le montagne e crea una cesura/frattura nel film.

I tuoi lavori video (correggimi se sbaglio) mi sembra partano sempre da un approccio documentaristico e a livello visivo sfruttino una grammatica cinematografica classica, quasi hollywoodiana. Ti ritrovi in questa definizione? Se sì, è una scelta voluta o è solo il tuo modo di approcciarti al lavoro?
Hollywoodiano non proprio, però potrei dire che mi avvalgo di una fotografia d’impostazione più classica, con l’uso di dettagli iper-ravvicinati e inquadrature statiche dai tempi lunghi. Cerco di distanziarmi – seppur richiamandolo – dal materiale fotografico e video altrui che spesso entra nei miei lavori a rovesciare il punto di vista. La mia intenzione è comunque rendere leggibile il tessuto visuale che compone il lavoro.
Il documentario è un dispositivo linguistico che gioca con il reale e ne descrive un incontro parziale tra soggetti mediato da immagini, oggetti, documenti e sonorità. Accogliendo diverse letture dell’immagine e della sua produzione contestuale, cerco di far rientrare punti di vista plurali che concorrono in dialogo, ad una destrutturazione narrativa corale.
Ad esempio le immagini che confluiscono nei miei video sono spesso il prodotto di dispositivi differenti, cellulari, “camerine”, macchine fotografiche di diversi periodi, con differenti risoluzioni e usati dalle mani più disparate, sono immagini realizzate in momenti e luoghi differenti, sino ad affondare le radici in forme di archeologia digitale o di ricerca in piccoli archivi cartacei semi-sconosciuti.
Nel mio ultimo progetto, Il cielo stellato, utilizzo proprio questo approccio alla molteplicità generativa dei dispositivi, che trasformano l’atto del registrare in una partecipazione attiva del soggetto che duplica digitalmente l’evento.

Il lavoro cinematografico si interfaccia per sua natura con il tempo, e con il movimento. Abbiamo appena attraversato un periodo nel quale il mondo intero sembrava essersi fermato, anche adesso tutto sembra rallentato, credi che questo stop forzato entrerà nel tuo lavoro? Se si, come?
Penso sia necessario comprendere che cosa voglia dire fermarsi, qual è il pensiero che porta ciascuno a riconoscere un tempo sospeso. È molto probabile che nel mio lavoro rientreranno maggiormente le conseguenze, le aporie che tale cesura ha generato, con la necessità di un nuovo linguaggio per rileggerne le tensioni strutturali stanno emergendo ora tutte assieme.
È evidente come la sospensione – o il rallentamento – del processo iper-produttivo nel quale tutti viviamo, abbia lasciato scoperti nervi e muscoli che ora si contraggono per reclamare il proprio spazio. Non è un caso che proprio in questo periodo emergano con forza diverse istanze a tutela dell’ambiente e dei diritti umani con un processo attivo di rilettura della Storia e dei suoi prodotti sociali da troppo tempo cristallizzati e ignorati.
Come il cinema – essendo comunque un dispositivo culturale frutto di processi che articolano e definiscono linguaggi e messaggi – accoglierà tali processi, è una delle sfide per immaginare futuri possibili. Dal canto mio vorrei un cinema più inclusivo che tenga in maggior considerazione sguardi tangenti e liminali, che interroghi il fruitore e lo renda attivamente partecipe, che adotti un approccio multidisciplinare dove l’arte contemporanea può essere un terreno fertile di sperimentazione visuale e filosofica.

In una tua intervista per Fondazione 1953 parlavi della memoria come di un elemento “plastico, che cambia in base al contesto in cui viene calato”. Vorrei che mi spiegassi che cosa intendi con questa frase, e in che modo questa idea si lega sia con il cinema sia, soprattutto, con gli archivi.
Da quell’intervista è passato qualche anno e ho fatto esperienze che credo mi abbiano cambiata. Tuttavia rimane con costanza l’idea che la memoria sia un racconto fuori fuoco di sé, calata nelle immagini, nelle cose, nello spazio urbano, nelle fotografie, nei testi scritti o in un messaggio sul cellulare conservato per pochi giorni, forse per anni.
La memoria è un processo: si può depositare in forme e si può anche dimenticare, limare, modificare, reclamare, esercitare oppure abolire, censurare sotto un velo di vergogna, mutilare sotto il dolore della perdita, oppure può essere completamente inventata.
La memoria ci definisce come individui, si esprime ed è frutto delle relazioni che la attivano, perciò diventa contestuale, particolare o collettiva se diventa immaginario – quindi riconoscibile come espressione di un processo culturale in cui ci si identifica. In questo senso la memoria diventa un bene comune che si lega alle azioni che la interrogano e la attivano, quindi è soggetta al cambiamento per cui diventa plastica/mobile, assume diverse forme in divenire e veicola messaggi e storie.
Cogliere la memoria e registrarla per trasmetterla fa parte di un approccio documentario e archivistico, per cui non esiste una singola chiave di lettura, ma un insieme di voci sempre inedite che la interrogano e ne definiscono di volta in volta il racconto.
Il lavoro documentario è un processo di negoziazione e interrogazione continua della memoria di tipo etico, nel chiedersi cosa resta e cosa viene perduto. Quella sottile linea di demarcazione è il luogo attorno al quale cerco sempre di indagare.
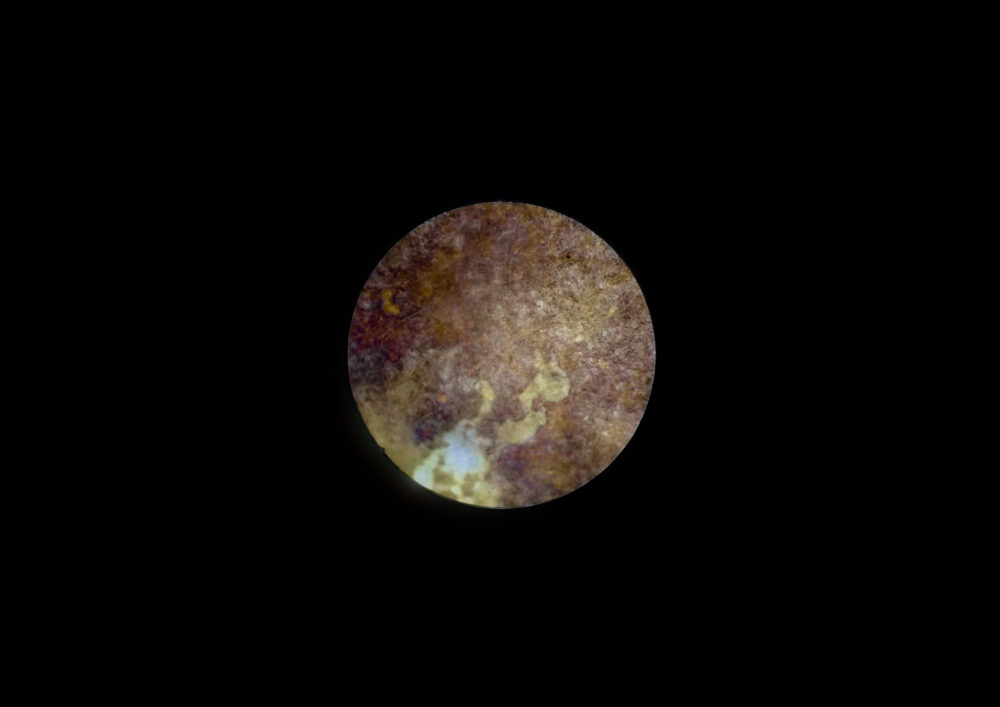
Insieme a Liryc Dela Cruz, sei vincitrice del premio Torino Social Impact Art Award 2020, che prevede una residenza da Combo, a Torino, in settembre e la creazione di un’opera-video da esporre ad Artissima 2020. Per l’occasione hai presentato il progetto Talking About Visibility: cosa intendi con ‘visibility’? In che modo il concetto di “visibilità” si incastra all’interno del tema di quest’anno: “QUANTE ITALIE”?
È una domanda, afferma indirettamente che ce ne siano molteplici oltre la narrazione unitaria nazionale. Cosa è Italia, allora? È una definizione costituzionale che garantisce alcuni diritti fondamentali, per cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e li ascrive ad un principio di legalità e uguaglianza di fronte alla giustizia. Uguaglianza è un termine utopico, indica una tensione, un processo. Tuttavia secondo il filosofo Byung-Chul Han in L’espulsione dell’Altro, l’uguaglianza è un principio che inscrive il singolo in una logica economica basata sullo sfruttamento e la discriminazione trasversale tra chi produce ricchezza e chi no. Si evince che la visibilità sia strettamente interrelata alla concetto di legalità: rendersi visibili è un modo per proclamare il proprio diritto di esistenza ma, al contempo, tale esposizione rischia di sottoporre i soggetti alle norme giuridiche vigenti. Il tema della visibilità perciò si relaziona alla rappresentatività, che significa avere la possibilità per poter auto-rappresentarsi nello spazio pubblico e privato, immaginarsi e veicolare narrazioni.
All’interno di questa cornice ho sentito la necessità di trovare un terreno di dialogo comune, che restituisca un discorso che dal personale si possa fare collettivo.
Per rispondere al tema del bando, ho trasformato la domanda in “quanti immaginari?” e ho individuato nel background visuale cinematografico di ciascuno, quel terreno di dialogo comune.
L’intento è creare un momento per il racconto – in Talking about visibility in forma laboratoriale e sperimentale finalizzata alla produzione di un video collettivo e corale – su quei ricordi di film, che dopo lunga migrazione, forse non verranno più visti. La perdita dei propri punti di riferimento visuali e l’immaginario a essi connessi, implica un processo di ri-appropriazione mediante la ri-contestualizzazione di storie all’interno dello spazio pubblico che ci circonda.
L’Italia è composta dagli immaginari che la costruiscono, per cui renderli visibili vuol dire smussare e fratturare l’idea storicizzata e cristallizzata dello Stato Nazione. Talking about visibility va al centro di questa riflessione.
Questo contenuto è stato realizzato da Marco Bianchessi per Forme Uniche.
http://www.caterinaericashanta.it/
https://www.instagram.com/caterina.shanta/
https://www.torinosocialimpact.it/