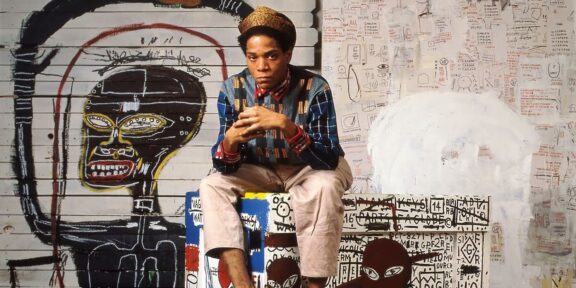Living, Oliver Hermanus e Kazuo Ishiguro alle prese col remake di un classico di Akira Kurosawa. Al cinema
Living, presentato lo scorso gennaio al Sundance Film Festival, è il primo film di Oliver Hermanus (Moffie) a non avere un’ambientazione sudafricana. Si tratta del remake di Vivere (1952) di Akira Kurosawa, liberamente tratto a sua volta dalla novella La morte di Ivan Il’ič di Tolstoj. La storia è pressoché la stessa dell’originale, ma si svolge nel Regno Unito anziché in Giappone, un trasferimento spaziale che sembra riecheggiare nel doppio retaggio dello sceneggiatore, il premio Nobel Kazuo Ishiguro.
Sembrano esserci tutti gli ingredienti per un successo: non solo una nutrita schiera di talenti sia dietro che davanti alla cinepresa, ma anche una storia dall’impatto emotivo garantito, già collaudata in un film meraviglioso a cui il remake potrebbe portare un nuovo, meritato pubblico. Purtroppo, Living soddisfa solo in minima parte le sue premesse e resta probabilmente destinato a rimanere all’ombra del suo predecessore. La struttura tripartita ricalca quasi esattamente quella di Vivere. Il primo atto introduce il protagonista, qui chiamato il signor Williams (Bill Nighy), un impiegato statale in cui ogni briciolo di vitalità ed entusiasmo è stato schiacciato dalla ripetitività e dall’inefficacia dell’ingranaggio burocratico, di cui è diventato una sorta di simbolo vivente. La sua vita viene sconvolta dalla diagnosi di un cancro incurabile e dalla scoperta di non avere che pochi mesi di vita. Già in queste scene introduttive il paragone con il film di Kurosawa non fa al remake nessun favore. Il signor Williams è prima introdotto a distanza, attraverso lo sguardo ossequioso e un po’ intimidito dei suoi colleghi, e solo in seguito avvicinato allo spettatore. Questo approccio costruisce attorno al personaggio un’aura di eccezionalità che mal gli si addice: una caratteristica fondamentale del protagonista dell’originale, il signor Watanabe, era proprio il fatto di essere uno fra i tanti volti grigi e inespressivi di un sistema guasto. Aumentare la distanza tra il signor Williams e gli altri personaggi che compongono il suo ambiente è il primo passo in una direzione individualizzante che si intensificherà nel secondo atto, incentrato sui tentativi del signor Williams di dare un senso a quella vita che sente di aver sprecato, affidandosi prima a uno scrittore sfaccendato e poi a una sua giovane, estroversa ex-collega (Amy Lou Wood di Sex Education).
Il film originale raccontava la storia di un everyman, e i personaggi da lui incontrati erano ulteriori simboli: lo scrittore rappresentava la promessa di una vita libera, senza regole, ma in ultima analisi fine a sé stessa, mentre l’ex-collega era chiaramente l’immagine della gioventù, dell’entusiasmo e della gioia di vivere. Erano stereotipi, in maniera intenzionale e perfettamente efficace; il nuovo film, invece, cerca di darne un ritratto più realistico, vuole trasformarli in personaggi di una storia e non in figure di una parabola. Al tempo stesso, la pedissequa fedeltà alla trama del predecessore impedisce alla sceneggiatura di rivoluzionare realmente questi ruoli. In sostanza, sempre stereotipi rimangono, ma senza quella precisione di intenti che li faceva funzionare. Il paragone con il film di Kurosawa penalizza quello di Hermanus anche in altri campi. Per esempio, i vagabondaggi del protagonista e dello scrittore sono raccontati nell’originale con un’intensità e una ricchezza espressiva di cui il remake può offrire solo una pallida imitazione.
Il terzo e ultimo atto, invece, è collocato dopo un salto temporale di mesi e si incentra sui tentativi delle persone vicine al signor Williams di ricostruire e comprendere le azioni del protagonista, cercando di mettere insieme le rispettive esperienze. Una sorta di Rashomon al contrario, in cui le varie storie non generano ulteriori ambiguità ma vanno a costituire un unico grande puzzle. Se gran parte del terzo atto, nel film originale, si svolge in un unico luogo, la sceneggiatura di Ishiguro sceglie di frammentarla sia dal punto di vista spaziale che da quello temporale, dissipandone l’impatto. Inoltre, sebbene gli eventi siano fondamentalmente gli stessi, il loro ordine è alterato per chiudere il film con una nota più ottimista, forse persino stucchevole. Neanche in questo caso Living regge confronto con Vivere, che si chiude con un’emozionante, irrisolvibile contraddizione.
In un certo senso, malgrado i suoi meriti tecnici ed estetici (come i bellissimi costumi di Sandy Powell), Living resta un film sospeso tra due tensioni opposte: da un lato, il rifiuto di discostarsi troppo dalla pellicola di Kurosawa fa sì che difficilmente gli si possa attribuire un’identità completamente autonoma; dall’altro lato, le poche modifiche di rilievo sanciscono indiscutibilmente la superiorità dell’originale. Bill Nighy, tuttavia, ne esce a testa alta con una prova ben diversa da quella di Takashi Shimura e quasi altrettanto commovente. Anche chi non sarà convinto dal film difficilmente potrà guardare la sua prova attoriale e rimanere a occhi asciutti.