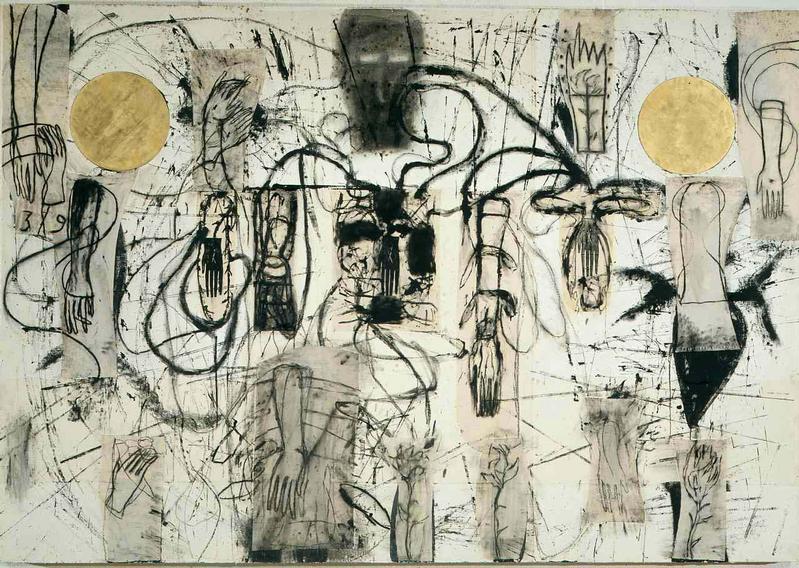L’artista Ernesto Jannini interviene nel dibattito aperto da ArtsLife dopo il corsivo pubblicato da Achille Bonito Oliva su Robinson di Repubblica
Dunque l’artista fuori dal sistema dell’arte, secondo Achille Bonito Oliva, è un isolato e le sue opere non hanno alcun valore in sé. Questo artista, “produttore d’immagini” vive nel suo mondo perché “non riesce a comprendere l’esistenza di una condizione filosofica dell’arte… calata all’interno di un contesto molto articolato suddiviso in lavori specializzati”. Vale a dire: musei, collezionisti, mercato, media, pubblico che – chiarisce l’ideatore della Transavanguardia – “crea un plusvalore culturale che travalica anche la qualità stessa dell’opera”. Entrando nel vivo della questione sollevata da questo corsivo apparso su Robinson di Repubblica, che ha suscitato varie risposte da parte di artisti e operatori del settore, direi che la prima riflessione coincide con una lapalissiana constatazione. Infatti, gli assunti di base della tesi non aggiungono nulla di nuovo poiché già reiterati nei decenni precedenti.
Va pure considerato che chi ha sostenuto quel sistema, è conseguenzialmente indotto a confermarlo. Pertanto ABO sembrerebbe limitarsi a descrivere lo stato delle cose. E quindi per questa ragione non è indotto a metterlo in discussione; anzi, in un certo senso deve confermarlo “assiomaticamente”, come ha ben evidenziato su queste pagine Roberto Gramiccia. Precisando che il sistema dell’arte/mercato, come le basi del “capitalismo finanziario e cognitivo, è venuto naturalizzandosi, come fosse una realtà assiomatica e indiscutibile…ma in realtà NON LO È. Aggiungendo che tale sistema “è una forma particolare di quell’industria culturale che segue le leggi del mercato e del sistema capitalistico. E, in quanto tale, si disinteressa della qualità e si occupa esclusivamente del business e dell’accumulazione, fino a teorizzare che tutto può essere arte”.
La dimensione dell’arte
E qui mi fermo, aggiungendo che per una sorta di “legge di natura” – mi si perdoni l’espressione – chi è all’interno di una certa visione antropologica culturale e scientifica tende a non mettere in discussione i postulati che sono alla base del sistema o, se si vuole, del paradigma. Ora si sa che i paradigmi, i sistemi culturali scientifici (Thomas Kuhn docet) ed economici iniziano ad indebolirsi, se non addirittura a crollare, quando le nuove istanze che avanzano, vengono supportate da una elaborazione di critica radicale che mette in dubbio lo stato delle cose, orientando la ricerca verso una più esaustiva comprensione del reale, anche se provvisoriamente esaustiva.
Insomma, si relativizza e si crea distanza dall’immanenza di una realtà che sembra schiacciare, se non addirittura sopprimere, altri possibili “modelli”. E questa storia vale anche per l’arte. O meglio: per i sistemi che gestiscono la dimensione dell’arte; gestione che è strettamente legata all’esercizio di un potere culturale e politico. Il che, nel caso del sistema/mercato, quando agisce in mala fede, vuol dire: da un lato portare alla massima potenza le prestazioni edulcorando, ingigantendo i valori effettivi che giocano in campo; dall’altro, disconoscendo, ignorando, oscurando tutto ciò che, al di fuori di quel sistema, si manifesta in una “forma” differente.
Il coraggio di giudicare
E qui si potrebbero nominare gli “attori” del sistema/mercato, che fanno capo ai grandi collezionisti capitalisti che con i milioni di dollari contribuiscono all’innalzamento dei prezzi per l’arte contemporanea. Mi riferisco ai manager degli hedge funds creatori di un wall power; alle figure dei trustee che, per le loro donazioni-sgravi- fiscali, occupano all’interno dei grandi musei una posizione di potere non secondaria ecc. ecc.. Infatti tutto ciò è ormai cosa nota, come è noto l’hype che sta dietro tutto il fenomeno. Del resto le dinamiche e le contraddizioni del sistema/mercato dell’arte sono state già da tempo messe in evidenza da un’ampia letteratura, tra cui mi piace ricordare alcuni titoli come ART MANIA di Piroschka Dossi; o Mercanti d’aura di Alessandro Dal Lago e Serena Giordano, che affrontano la questione delle “logiche dell’arte contemporanea”, mettendo in evidenza il fatto che l’”aura” dell’artista – che “vende bene”- è un espediente che nel sistema/mercato ha a che fare più con il packaging, ovvero una confezione comunicativa delle merci, che con l’ecfrasi dei valori in campo.
Denunce che mettono pure in evidenza l’arretratezza di un altro importante “attore” del sistema: cioè il critico d’arte. Il venir meno all’esercizio del pensiero critico – a sentire Carla Benedetti – è un vero e proprio “tradimento dei critici”, perché come sostiene nei suoi scritti “esiste nel pensiero, e quasi direi nella vita biologica e nei corpi, una tensione all’apertura altrettanto forte di quella che spinge alla conservazione del dato e dell’acquisito. Carlo Emilio Gadda la chiamava ‘euresi’, o anche, con formula logica, un tendere dell’N verso l’N+1, dove N sta per l’acquisito e l’N+1 per l’acquisendo, ancora ignoto… Questa pulsione… è secondo me anche l’impulso della critica”. Dunque “criticare” dovrebbe corrispondere ad una “vocatio”: parole di Edoardo Di Mauro (direttore uscente dell’Accademia Albertina di Torino) riscontrabili nel suo “Vocazione e progetto” poiché “si innesta sul coraggio di giudicare”.

Addomesticare l’arte
Quindi, venendo meno questa funzione, è lecito pensare come Marco Tonelli, che su queste stesse pagine – citando Nathalie Heinich – afferma che “a parlare fondatamente di arte non possono essere gli agenti del sistema dell’arte, troppo ‘endogenizzati’, cioè complici del meccanismo perverso del sistema stesso. Ma quelli che credono nell’unicità e nella dirompenza dell’opera d’arte e degli artisti”. Dunque, ciò su cui a mio avviso è opportuno tornare a riflettere, è se per caso questa potenziale “dirompenza dell’opera” non venga compromessa dal sistema che, stando a molti osservatori, tende da tempo ad appiattire, omologare, uniformare e in ultima analisi – come ebbe a dichiarare Massimo Cacciari al Festival di filosofia di Sassuolo del 2017 sul tema della “fine dell’arte” – ad “addomesticare” l’arte e quindi ad appiattirla. A renderla – pensiero di ABO – “una” componente del sistema, un fatto residuale.
Credo, a questo punto, che la vexata quaestio sposti ulteriormente l’asse della riflessione anche sulla responsabilità spirituale dell’artista, produttore di immagini e di oggetti in un mondo in cui esiste “anche” il mercato con il suo sistema. Il che vuol dire che la sfida per lui sta nel vendere senza vendersi in quanto, in questo ultimo caso, si configurerebbe una sorta di “tradimento spirituale” rispetto alla necessità primaria della ricerca artistica che – va detto per inciso – non è per niente aliena dalle condizioni storiche e dalle necessità materiali e del denaro, ma queste ultime le utilizza per un fine superiore. Infatti, in tal caso – ribadisce Cacciari – si andrebbe a perdere la tensione alla ricerca della “parola che manca” poiché è in questa tensione che “abita” l’arte. “Se questa condizione non l’avvertiamo più come necessaria, allora non ci trascendiamo più; dell’esserci come trascendenza. Noi, come trascendenza, se questa parola che manca non è più ascoltata… Nella parola che manca nell’arte sta il segreto del non essere addomesticabili. Non stiamo qui a casa, nelle merci, nel mercato”. Il quale, precisa il filosofo, ha ovviamente la sua legittimità ad esistere e nessuno lo può negare.
Quando ha origine l’opera?
Il punto dunque è l’arte che, non ultimo, deve fare i conti, innanzitutto col paradigma della scienza che informa tutto il reale; quel reale che deve essere messo continuamente in discussione, compreso il nostro caro sistema/mercato. Perché – aggiunge il filosofo – “dopo Hegel l’arte non può essere più vista come divertimento, un godimento soggettivo… È proibito, filosoficamente proibito… Un’arte che trova la sua necessità in mezzo al mondo in cui prevale il paradigma della scienza”. Ed è ciò che è accaduto – aggiungo io – con tutti i “movimenti” artistici a partire dalla metà dell’ottocento ad oggi.
Dunque l’arte – come si evince dal dibattito filosofico ed estetico ormai in corso da anni – è un concetto ancora tutto da approfondire; come pure Heidegger e Gadamer avevano fatto, spostando la domanda dal “che cos’è l’arte” a “quando ha origine l’opera”; o, come sostiene più recentemente il filosofo britannico Nick Zangwill, il quale afferma che “potrebbero esserci parecchi concetti di arte da analizzare”. A questo punto la pretesa assiomatica di ABO rischia di essere troppo apodittica e maliziosamente autoreferenziale, visto e considerato che il sistema/mercato mostra il limite del suo recinto, per quanto ampio esso sia. O, tutt’al più, la sua relativa verità che si muove in un mondo dell’arte in cui il pluralismo espressivo viene spesso confuso con il tutto possibile.
La critica istituzionale
Il sistema/mercato, di cui non si mette in discussione la legittimità ad esistere, perché sarebbe un assurdo, è un contesto, con le sue procedure legittime e illegittime che rispecchiano in parte la teoria istituzionale del filosofo americano Georgie Dickie, essendo il “mondo dell’arte” una “semi-istituzione”. Ma le forme della manifestazione artistica sono svariate, tant’è che non ci sono ragioni necessarie e sufficienti per dimostrare che quella del sistema/mercato sia l’unica. Fuori di esso si manifestano e si sono manifestate altre realtà artistiche, anche nel passato. Purtroppo sistematicamente “affossate” per le perverse dinamiche di cui sopra. Perchè non spendibili e accalappiabili sul piano economico. Forme e modi differenti fuori dai recinti, già iniziate nei lontani anni settanta. Infatti, e non ultimo, sarebbe interessante, per esempio, riaprire la questione ripercorrendo la storia della Istitutional critique già avanzata nel lontano 1975 da Mel Ramsden e da Peter Bürger (famoso per la sua Theorie der Avantgarde), come ha fatto diligentemente in questi giorni Stefano Taccone con il suo “La critica istituzionale” uscito per i tipi di Ombre Corte con lucida prefazione di Stefania Zuliani.
E dunque non c’è nulla che non possa essere criticato apertamente e profondamente. Abdicare a questa funzione significa uniformarsi e, per gli operatori del sistema, trasformarsi in funzionari servili a rischio zero. Invece bisogna giocare ad aprire e non a chiudere, come si evince dalle affermazioni, ormai fuori tempo, di ABO. Naturalmente se gli artisti accettano acriticamente le premesse del sistema/mercato rimarranno bloccati in una sorta di incantesimo paralizzante e non ne verranno fuori; fuori da quella frustrazione o rassegnazione, una sindrome depressiva che sembra colpire gli artisti che si sentono schiacciati dal sistema; sintomi inquietanti, equivalenti alla dissipazione delle forze in campo.
La dirompenza del gesto creativo
Ciò che è fortemente criticabile nelle affermazioni di ABO è il fatto che quel pensiero trascina con sé il germe della “semplificazione” riducendo la complessità del reale artistico e antropologico in un “recinto” coincidente con il sistema/mercato, mentre la realtà è uno “gnommero” come direbbe Carlo Emilio Gadda: un groviglio a cui accostarsi con più umiltà e onestà intellettuale; una realtà in cui – simile ad un bosco – non prevalgono solo le piante di alto fusto (o presunte tali); in cui la vita reale è fatta da particolarità e singolarità molteplici, difficili da ingabbiare in una tassonomia di mercato. Un paradigma, quello cavalcato da ABO, che chiude ad altri possibili mondi, mentre il pensiero-arte può farsi “aurorale” a sentire Umberto Galimberti.
Infatti, poiché oggi non c’è più distinzione tra fare arte e fare critica è necessario giocare ad aprire e non a chiudere e quindi obbligatorio recuperare il rapporto con la vita reale nei luoghi ufficiali e non ufficiali, nelle chiese sconsacrate, nei parchi, nei teatri, nelle piazze, nelle scuole di ogni ordine e grado a contatto con i giovani, con le comunità montane, con le realtà più lontane dai City Life; ma anche in questi ultimi se si è in grado di intervenire con la dirompenza dell’opera d’arte, del gesto creativo. Incominciare a pensare che gli uomini sono più liberi di quello che pensano – come sosteneva pure Faucault – e che tutte le “evidenze” sono costruzioni determinate dalla storia ma tutte sottoponibili ad una critica radicale.