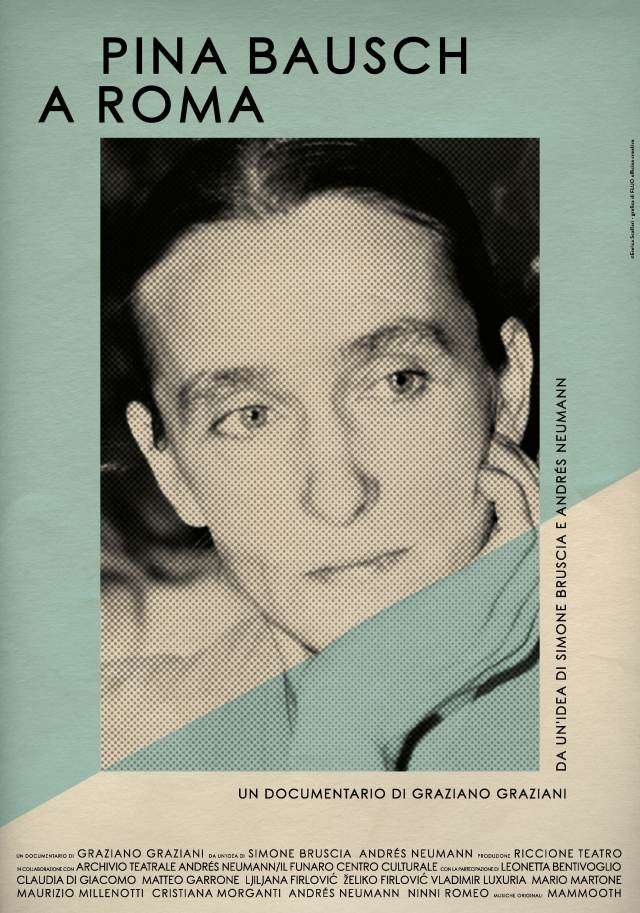La nuova sede di Monitor Gallery, da poco traslocata in zona San Lorenzo a Roma, ospita la collezione dei Fratelli Gianni e Giuseppe Garrera per una mostra intitolata “Paura della pittura”, in cui una serie di pezzi storici – dai Acci, Celada e Chighine, tra gli altri – dialogano con alcuni artisti contemporanei, da Matteo Fato a Elisa Montessori
Nel 1942 uscì un numero di «Prospettive», periodico diretto e fondato da Curzio Malaparte, intitolato Paura della pittura, e contenente interventi di Renato Birolli, Luigi Bartolini, Paul Éluard, Emile Bernard, Aligi Sassu, Antonietta e Mario Mafai, Renato Guttuso. È peraltro lo stesso numero della rivista che potete riconoscere ritratto in una natura morta di Francesco Trombadori degli anni Quaranta. E quel numero lo potete ritrovare in questi giorni esposto nella mostra omonima (visitabile fino al 22 aprile 2023) che occupa i nuovi e ariosi ambienti della Galleria Monitor Roma, da poco traslocata nel quartiere di San Lorenzo.
Da lì infatti è partita l’idea dei curatori della mostra, i fratelli e collezionisti Gianni e Giuseppe Garrera, di creare un percorso attraverso la pittura, e soprattutto impostando possibilità di dialogo tra i dipinti di personalità sia storicizzate, sia viventi che quella pittura la praticano o la hanno praticata nonostante la paura, senza paura, o proprio spinti dal bisogno di sfidare quella paura, e senza l’aiuto, almeno credo, di lunghe sedute dall’analista. La paura di cui si parla, e non si ha paura di citare Guttuso proprio dalle pagine di quel numero di «Prospettive», è la «paura degli amici, dei nemici, dei critici, dei mercanti, della propria cultura, dei libri che si son letti, del ‘breviario di estetica’, dei quadri che si son visti e di quel che è stato detto e scritto su quei quadri, paura di se stessi, del proprio passato e del proprio avvenire, paura dell’illustrazione, del decorativismo, del naturalismo, del sentimento, dell’imitazione, paura dell’oggetto come oggetto, paura d’essere nella moda e paura d‘esserne fuori”».
Le regole sono piuttosto semplici. Sono stati scelti, nella collezione Garrera, alcuni dipinti di artisti storici gravitanti intorno alla scuola romana, come Giovanni Acci, Ugo Celada, Alfredo Chighine, Virgilio Guzzi, Walter Lazzaro, Giovanni Omiccioli, Domenico Purificato, Ada Schalk. Tutti i dipinti sono di formati contenuti, tipici di una dimensione domestica e borghese della pittura, e con quelle misure si sono dovute confrontare le nuove creazioni degli artisti viventi, Elisa Montessori, Thomas Braida, Matteo Fato, Nicola Samorì.

6 of 16
Nasce da questo confronto un colloquio tra pittori, vivi e morti, sul fare pittura al di là dei tempi, in cui ogni singola voce sembra rimbalzare da un punto all’altro dei locali della galleria, senza ordine o gerarchia apparenti, oppure si creano dinamiche dialogiche tra due o più opere specifiche, accomunate magari da uno stesso tema, appiglio funzionale a evitare che la pittura si perda nell’astratto. Si vaga così, ora attratti da un infuocato e magico paesaggio di Acci, nel quale sembra di riconoscere qualche seme di visionaria deformazione di quelli coltivati anche da Carrà o da Cucchi, ora perdendosi nei baluginii esistenziali di Chighine, quasi un Nicolas De Staël ma con meno sole, ora intimoriti dall’austerità del barocco spagnolo digerita e messa in scena nelle tele di Samorì, ora disorientati dal furore espressionista, e così carico affettivamente, del Fato dei Florilegi.

Riguardo i tête-à-tête più intriganti, una Dormitio di Samorì affianca un bel nudo di Schalk, mentre una natura morta appena strappata dal nero, sempre sua, battibecca con soggetti omologhi di Omiccioli – un vaso di fiori ammantato di una calda luce pomeridiana –, di Braida – il cui Fiore avaro gioca con una resa del dato luminoso tutta mentale –, e di Montessori – che invece filtra la rappresentazione dei fiori attraverso una stilizzazione su fondo oro di sapore squisitamente orientale. In un’altra sala, poi, altre nature morte si fanno araldi di differenti registri di mano, suggerendone inedite affinità elettive, ma estraneità elettive mai, perché alla fine si parla sempre di pittura, e occorre, per dirla con Maurice Denis, «ricordarsi che un quadro, prima di essere un cavallo da battaglia, un nudo o un aneddoto qualunque, è essenzialmente una superficie piana coperta da colori disposti in un certo ordine…».
Piacerebbe leggere quel pitturare senza paura degli artisti esposti in mostra anche come affermazione di una libertà senza paura, e il ribadire la propria presenza nel mondo, quasi una (ri)appropriazione di quello. È una chiave di lettura che possiamo tranquillamente rubare a Carlo Levi, un cui testo sulla paura della pittura avrebbe dovuto essere tra gli quelli compresi nel numero speciale di «Prospettive» del 1942, ma non si fece poi in tempo a pubblicarlo (l’artista lo lesse dai microfoni di Radio Firenze nel 1944, alla fine della seconda guerra mondiale). Il pittore, antifascista, partigiano, ebreo – da cui, per cultura, un rapporto problematico con l’immagine –, costretto a emigrare in Francia per le leggi razziali, metteva acutamente in relazione la paura della pittura con la paura della libertà e con l’idea di un mondo in cui l’uomo era divenuto assente, nell’era più cupa dell’ascesa dei fascismi. Poichè, scriveva Levi, «costretti a vivere, ad accettare la vita in un mondo da cui si è assenti, assenti dunque e estranei a noi stessi, avvolti dalla solitudine, nessuna passione ci è consentita se non il terrore. Il terrore fondamentale e primordiale, la paura del mondo, della vita, della libertà, dell’uomo: la Paura della pittura».