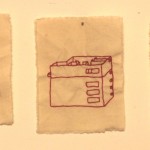Di nuovo IN LABO, questa volta per incontrare Violetta Uboldi (Monza, 1987). Nel suo angolo di studio sono allineate polveri colorate, pigmenti che mi mostra con orgoglio, parlandomi con entusiasmo di questo spazio condiviso.
Di nuovo IN LABO, questa volta per incontrare Violetta Uboldi (Monza, 1987). Nel suo angolo di studio sono allineate polveri colorate, pigmenti che mi mostra con orgoglio, parlandomi con entusiasmo di questo spazio condiviso.
È il tuo primo studio?
«Sì, qualche mese fa ho iniziato a fare un lavoro mastodontico per la mia tesi ed è capitato a pennello. La realizzazione del progetto, intitolato “Le mie galle”, è stata molto lunga, così come per tutti i miei lavori, forse perché ho bisogno di tempo per metabolizzare. Oggi è diffusa l’idea che la creazione sia secondaria, mentre io sono convinta che il materiale debba essere vissuto, a volte in modo doloroso. Ho deciso di recuperare l’argilla nelle cave, filtrarla, correggerla, per realizzare delle forme architettoniche, che ho cotto in un forno a legna costruito da me, ecco perché alcune sono un po’ distrutte. Due elementi potentissimi, la terra e il fuoco, interagiscono e producono un risultato in cui c’è una componente di imprevisto».
Eri, dunque, interessata al processo?
«Indubbiamente il processo mi interessa, ma non sono uno di quegli artisti che sacrifica il risultato finale, non sono attratta dalle forme d’arte performative. Nonostante io abbia parlato di imprevisto, sono convinta si debba conoscere la materia e sapere come controllarla, per cui il procedimento non può essere separato dal prodotto. Quello che speravo potesse trasmettere un lavoro come “Le mie galle” è il fatto che esso parla di un procedimento precedente, ne registra la storia».
A livello formale il risultato sono strutture architettoniche instabili, però il titolo rimanda ad altri significati.
«Sono un’appassionata di documentari sugli insetti e ho scoperto che esiste una vespa che con un lungo pungiglione infila le sue uova in alcune piante che stanno crescendo – in Italia una delle specie più comuni agisce sulle querce. Questo insetto modifica la struttura dei frutti, le ghiande nell’esempio delle querce, trasformandoli in strutture lignee, dure e resistenti, che proteggono e nutrono, come strumento di difesa reciproca.
Le figure architettoniche sono immagini di periodi della mia vita che considero le mie galle, che mi hanno fatto da guscio e io ho modificato. Mi piace però l’idea che se ne possa dare un’interpretazione diversa: non voglio descrivere ossessivamente il mio lavoro, perché c’è una poetica dell’imprevisto sia nella realizzazione sia nel risultato finale sia nel modo in cui verrà letto dal pubblico».
Il richiamo all’urbanistica è presente anche in altri tuoi lavori. Usi l’architettura come metafora?
«L’architettura è una parte integrante di me, la città è un elemento fondamentale, un grande organismo con molti aspetti nascosti. Le città, pur avendo un carattere, sono innanzitutto un simbolo universalmente riconoscibile, anche a livello emotivo, componente che nel mio lavoro è molto presente. Una città ha un’emotività forte, perché rimanda a una storia: noi siamo legati ai luoghi e i miei luoghi sono la città.
Dopo “Segni di Milano”, una serie di piantine ricamate, sto realizzando un altro ricamo di Milano, tre grandi pannelli che rappresentano la vista da casa mia. Un regalo per la mia città. Quando lavoro sono molto coinvolta, partecipe e mi sento sempre di dovere qualcosa a ciò che mi ha reso così. Sono grata a Milano».
L’urbanistica è presente anche nella serie di sculture “Piccole città”.
«È un lavoro sulle città in cui ho vissuto: Londra, Valencia, Granada. Abitare in luoghi diversi permette di scoprirne il carattere. Sono, in realtà, dei vasi, in cui il coperchio diventa un gioiello, avvicinandosi al design. Li ho realizzati in ceramica, uno dei materiali che prediligo, perché rimanda alla terra, perché permette un rapporto fisico e il lavorarla si trasforma in un esercizio di meditazione».
A proposito della componente emotiva sottesa ai tuoi lavori, essa viene esplicitata nei testi che li accompagnano. Ti riveli molto, come se permettessi di leggere un tuo diario.
«A volte faccio fatica a mettermi all’opera, perché implica un’autoanalisi che spesso preferisco evitare. Negli ultimi due anni ci sono stati alcuni momenti difficili, in cui, però, ho avuto la prontezza e la lucidità di scrivere. Rileggendo quegli scritti, talvolta non mi piaccio, non mi riconosco, ma sono contenta di essere riuscita a conservare una parte di me che altrimenti andrebbe perduta. Non credo che per l’artista sia necessario essere tormentato, ma penso che i periodi difficili fungano da motore, dando la possibilità di affrontare tematiche estranee alla vita quotidiana. La scrittura costituisce un materiale di lavoro, pur non essendo descrittiva dell’opera è parallela e complementare, perché deriva dallo stesso input. È da poco che ho fatto leggere a qualcun altro i miei pensieri ed è stata una prova di coraggio, un modo per ripartire».
Li avevi già, però, esplicitati almeno in parte in “Vittoria si ascolta”.
«L’opera è costituita da una serie di sculture che rappresentano degli uomini molto arrabbiati, il mio stesso stato d’animo durante la loro realizzazione e nel momento in cui sento sostenere che l’arte figurativa sia anacronistica. La maggior parte dei miei lavori derivano dalla mia formazione, che è stata caratterizzata da blocchi e divieti imposti dai miei docenti in Accademia. Sono, invece, convinta che un artista possa sperimentare qualunque soggetto e materiale. Sento l’esigenza di fare, dopo una generazione di artisti concettuali, per cui era sufficiente pensare.
Nel periodo in cui non realizzavo più nulla, perché ero condizionata e impaurita dai giudizi negativi, una mia amica, Vittoria, mi ha aiutato a capire come sia difficile ascoltarsi, sovrastati dai propri pensieri e dai pareri altrui. Ecco allora che ho realizzato una serie di uomini in ceramica che urlano, metafora sia della propria voce interiore, sia di quelle altrui che si sovrappongono».
Galleria immagini: