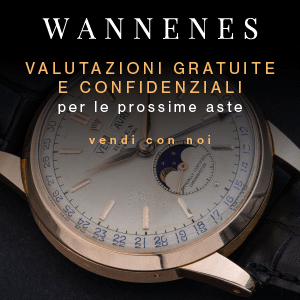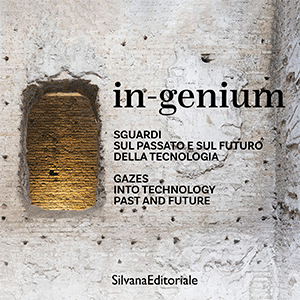Non ho mai capito perché guardiamo Sanremo. Ci restiamo attaccati persino quando appare il diversamente comico Alessandro Siani, l’imitatore fasullo di Massimo Troisi, «la quintessenza della banalità», come l’ha definito sul Fatto il più gentile dei suoi critici, Andrea Scanzi, una sorta di guitto triste adattissimo solo per i duetti con Elisabetta Canalis, che non staresti ad ascoltare neanche senza un cacchio da fare al bar. Non abbiamo cambiato canale neppure allora. Abbiamo aspettato una canzone che non arrivava, una battuta che non esisteva, una memoria che non ritornava.
Siamo rimasti tutti lì. Ed è strano come nella sua finzione orrorifica Sanremo appartenga interamente alla nostra identità e non solo al nostro immaginario. Lo dicono i numeri. Nella prima serata lo share medio ha raggiunto il 49,34 per cento di televisioni accese su Raiuno, cioé praticamente una su due, 11 milioni e 767mila spettatori, con un’età media pure bassa per il pubblico di pensionati che è solito frequentare la rete Ammiraglia, 53 anni appena. Leggera flessione nella seconda serata, 41,67 di share e 10 milioni e 91mila spettatori, ma addirittura 8 punti e due milioni in più dell’anno scorso. Il segreto del successo? Non esiste.
Basta rivedere le immagini di Al Bano e Romina, icone stanche di un’Italia dimenticata, gonfi e invecchiati, così patetici nell’inseguire la loro canzone della felicità mentre evitano, fra curve improvvise e smorfie malcelate, di incrociare gli sguardi. Non sono più marito e moglie, ma lo spettacolo può andare oltre la famiglia. Non conta quello che cantano, perché tutto è già dimenticato nel momento in cui si spegne la musica. Restano il volto rotondo di Al Bano, ispessito e immalinconito dal doppio mento, e il sorriso quasi sforzato di Romina.
La verità è che è inutile cercare il segreto del successo. L’edizione del festival più vista della storia di Sanremo è quella del 1987, con picchi di ascolto davvero bulgari, del 68,71 per cento, tipo a Livorno quando andavano a votare comunista (il motivo per cui Allegri stava antipatico a Berlusconi: se è livornese, vuol dire che è di estrema sinistra). Quell’anno vinsero Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri: cantavano «Si può dare di più».
La seconda più vista è quella del 1995, 66,42 di share. Il meno visto è del 2008, 36,56, Giò Di Tonno e Lola Ponce che trionfano, ma la terza messa peggio è proprio l’edizione dell’anno scorso, con la Litizzetto e Fabio Fazio, 39,26 per cento, che detiene pure il triste primato di annoverare la serata finale con il più basso indice di ascolto di sempre: 43,51. C’è un motivo per tutto questo? Hanno detto che quell’ultimo festival era troppo radical chic, fatto su misura per il pubblico intellettualoide e sinistrorso che sulla terza rete non abbandona mai «Che tempo che fa», una nicchia di pubblico non allargabile. Vero, falso? Forse sì, forse no.
La verità è che questo festival è molto più brutto, non solo di quello, ma probabilmente anche di tutti quelli prima, con le sue canzoni senza appeal e i suoi comici (comici?) del livello di Siani. Piace di più perchè Sanremo appartiene alla nostra famiglia, è dentro di noi, e non deve rompere equilibri o creare problemi, risse, polemiche troppo accese. Il suo presentatore quest’anno è perfetto, un modello di aziendalista senza mai uno scandalo, mai una lite, una minaccia di trasferimento, un’intervista velenosa. Sanremo racconta l’Italia. E hanno rimesso a posto il narratore.
Ma se è vero che il festival di Sanremo racconta l’Italia, come ripetono tutti gli osservatori e gli storici della canzonetta, c’è ancora qualcos’altro che non riusciamo a capire. Dal punto di vista musicale, la manifestazione sembra tornata indietro ai primi anni Sessanta, cioé al periodo che precedeva l’avvento dei cantautori e della musica impegnata. Con una differenza essenziale, però, che alcuni di quei brani sono rimasti nella memoria collettiva, e persino nel nostro linguaggio, da «Non ho l’età» a «Una lacrima sul viso», fino a «Nessuno mi può giudicare».
Quelli di adesso, faremo in fretta a dimenticarli. Dal punto di vista, come dire?, sociopolitico, invece, il festival confezionato dal normalizzatore di professione Carlo Conti sembra rimandarci agli scenografici anni Ottanta della Milano da bere, quando bisognava lasciar lavorare in pace il manovratore e pensare soltanto alla ricerca del tuo benessere. Erano anche i tempi di Berlusconi e della sua nuova televisione commerciale, nei giorni in cui l’Italia cominciava a riempire anche le camere da letto e le cucine di quegli schermi bombati nelle scatole nere che fino a poco prima se ne stavano quasi come iconoclastici trofei soltanto sui loro piedistalli in salotto.
Ebbene, la verità è che non ci sono decenni più distanti dal nostro di questi due. Siamo nel mezzo della più grande crisi del dopoguerra, figli e fidanzati spaventati della decrescita, con una paura fottuta del nostro futuro, più poveri e più meschini, ahinoi, immagini spente e dolenti di tutto quello che eravamo riusciti a vedere prima di finire dentro a questo girone. E allora?
Non so se sono luoghi comuni. Però stasera lo vedrò di nuovo, e non riesco a spiegare perché. Starò lì, sulla poltrona, aspettando una canzone che non arriva, una battuta che non esiste, e una memoria che non ritorna…



![Festival-di-Sanremo-2015-Carlo-Conti[1]](http://www.artslife.com/wp-content/uploads/2015/02/Festival-di-Sanremo-2015-Carlo-Conti1.jpg)