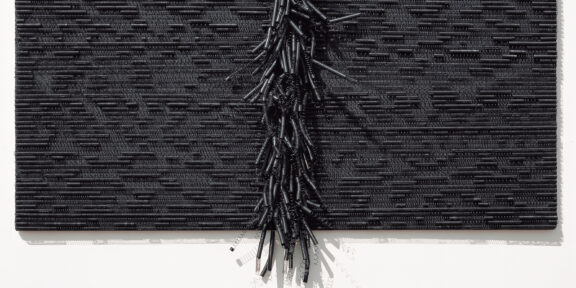Venezia 79, giorno 4 e 5: montagne di banalità in “The Whale” di Darren Aronofsky, piatto e retorico “L’immensità” di Emanuele Crialese
– Che fine hai fatto? Ieri niente dispacci dal Lido?
– Mi devi perdonare, ma avevo il cellulare a terra (la notte avevo infilato la carica nella presa sbagliata…). Non sto a dirti quello che ho dovuto fare per ripescare i biglietti digitali per le proiezioni prenotati online…
– Quindi riesci comunque a prenotare qualcosa.
– Certo. Tutto quello che voglio, ormai. Ti avevo detto che con un po’ di pazienza il sistema si sarebbe assestato entro un paio di giorni… Ed è stata anche una giornata intensa: 5 film. Vorrei parlartene senza rispettare l’ordine cronologico delle visioni. Cominciamo da “Master Gardener” di Paul Schrader. Dico subito che non arriva alle sublimi altezze di “The Card Counter”, visto qui a Venezia l’anno scorso, ma è pure normale che un regista ultimamente piuttosto prolifico realizzi qualcosa in scioltezza. Non sto dicendo con la mano sinistra, però. Questo suo ultimo, che ha accompagnato in Sala Grande la cerimonia per consegnargli il Leon d’Oro alla Carriera (stiamo parlando di uno che ha scritto “Taxi Driver” e ha diretto cult come “American Gigolo”), è uno Schrader comunque in stato di grazia. La storia, torvissima, è quella di un ex-mercenario con simpatie naziste e suprematiste (Joel Edgerton) che ha deciso di cambiar vita e occuparsi del giardino della casa coloniale di un’algida e ricca vedova un filo dominatrix (Sigourney Weaver). Lei gli affida la nipote di colore (Quintessa Swindell) perché le insegni ad aver cura di fiori e piante, strappandola alle sue pessime compagnie. Come un cercatore d’oro, Schrader setaccia lo schema e la struttura del classico finché non ne resti che la polvere d’oro, che lui emulsiona fino a farne un morbido unguento che avvolge la visione, accesa di rigogliose e fiorite metafore della vita e dei suoi riti di passaggio, perché la redenzione possa aver luogo. Se ne esce corporalmente purificati, come dopo una imporporinata doccia ayurvedica.
– Vedo insomma che stai vedendo parecchia roba buona, a questa Mostra…
– Come in tutti i Festival, si sale in vetta e si casca negli abissi della modestia e dell’inutilità. Tocca registrare infatti quello che almeno a tutt’oggi è il punto più basso raggiunto dal Concorso, “The Whale” di Darren Aronofsky. Uno di quei film per cui l’àplomb del critico può tranquillamente andare a farsi benedire.
– Ovvero?
– Una cagata di proporzioni cosmiche. Accolto da un applauso sonoro e sincero, almeno alla proiezione stampa in Sala Darsena.
– Ma davvero?
– Per dovere di cronaca riferirò che si tratta dell’adattamento cinematografico di una pièce teatrale ambientata interamente in una stanza (ma fin qui non v’è dolo alcuno: quanto cinema si può fare in un’unica stanza!) dove personaggi capaci di pronunciare esclusivamente montagne di banalità si scannano a vicenda rinfacciandosi, tra un piagnisteo e uno sbotto isterico, colpe e traumi da telenovela mesoamericana. Brendan Fraser (che fu un Tarzan avvenentissimo), obesizzato fino all’inverosimile dagli effetti speciali, sarà anche un candidato eccellente per la coppa all’interpretazione maschile, ma il contesto ribrezzevole ricreato da Aronofsky con il consueto gusto per il patetismo e per una sovraemotività prefabbricata a tavolino, impone un categorico rifiuto.
– Sui giornali si parla di Fraser come Oscar garantito, almeno come nomination…

– Ormai è questa la roba che trionfa agli Oscar… Restando al Concorso, le cose non migliorano con l’altro film italiano in corsa per un Leone: “L’immensità” di Emanuele Crialese. Inerte, provolone, impregnato di quella nostalgia facilona per il bianco e nero dei televisori degli anni ’70 e dei sabati sera canori con Raffaella Carrà, Celentano, Patty Pravo e Johnny Dorelli (riallestiti e coreografati in fotocopia con la stessa perizia inamidata con cui, negli stessi anni, i cartoni giapponesi si appropriavano dei grandi classici della letteratura mondiale per ragazzi spianando la strada al piattume della massificazione globalizzata dei patrimoni culturali d’Europa e del mondo intero) pretenderebbe di illustrare i turbamenti di una ragazzina nata per sbaglio in un corpo maschile. Una venuzza di autobiografismo, sembra, perché Crialese, già da parecchio uomo fatto e finito, da adolescente era una ragazza. Lo si sapeva un po’ tutti, ma solo qualche giorno fa egli stesso ha ufficializzato questa storia. Penelope Cruz ce la mette tutta, ma il film resta ingessato dall’inizio alla fine, ostentando una catatonia innaturale in linea, ahimè, con tanto cinema nostrano che si vedeva ai Festival, e che si credeva ormai sparito. Come ha detto un’amica che era con me alla proiezione, “ci sono bellissime carte da parati anni ’70, ma non c’è l’atmosfera degli anni ‘70”.
– Giornata grama, quindi. Gramissima.
– Ti dirò invece che “Monica” di Andrea Pallaoro, nel concorso ufficiale, sta facendo il suo lavoro a 24 ore dalla visione. Nei miei post di Facebook gli ho dato 6 su 10, ma ora sarei forse disposto ad aumentare di un voto. Noiosetto, per carità, senza mostrare alcun interesse nel tirare dentro la storia masse di spettatori paganti; però elegante, formalmente levigato, trattenuto nel racconto, vi si avverte l’intenzione di pedalare su toni bassi, quasi spenti. Eppure la protagonista, un trans dal fisico iperdonnesco e giunonico, e dal volto molto “lavorato”, diciamo, ma puntellato di due strepitosi occhi chiari, la sua fragilità, la dolenza nell’affrontare il cancro della mamma, il senso di esclusione dalla vita in apparenza serena dei pur più che amichevoli parenti stretti, mi hanno lasciato addosso un’umbratile, affettuosa tenerezza.
– Comunque sia, ieri, nessun capolavoro, a quanto pare.
– Ti sbagli. Me lo sono tenuto ultimo per chiudere in bellezza. Parlo di “The Kiev Trial”, di Sergej Loznitsa. Il regista ucraino prosegue il suo progetto di ricostruzione antropologica, etica e morale della Storia rimontando materiali d’archivio inediti, all’occorrenza risonorizzandoli, per dare l’illusione di un racconto degli eventi vivo, attuale, filmato in presa diretta. Il Processo di Kiev fu di poco anteriore a quello di Norimberga, e condannò a morte quegli ufficiali nazisti che si resero colpevoli dei ben noti spaventosi crimini in territorio sovietico. Si ascoltano le testimonianze degli imputati e dei testimoni oculari come fossero un unico mantra, ossessivo, allucinato, per esorcizzare i fantasmi di un passato che a ben guardare, basterebbe affacciarsi ora da una finestra qualsiasi per ritrovarselo sotto il naso, identico, folle, inspiegabile. E in quegli stessi luoghi…
https://www.facebook.com/people/Anton-Giulio-Onofri/1405664800