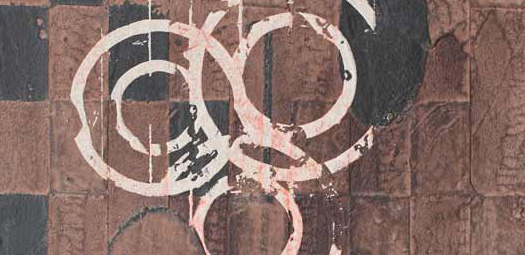Critici, artisti, direttori di museo, giornalisti, galleristi riflettono sui nuovi protagonisti di una scena dell’arte contemporanea un tempo presidiata dall’Occidente
Sì, lo sappiamo bene, le categorie – Occidente, terzomondo, periferia – sono da tempo materia archiviata dal dominante globalismo. Da decenni il dilagare della comunicazione ha azzerato ogni distanza, garantendo ad artisti, critici, studiosi di ogni angolo del globo pari opportunità di intervenire nelle dinamiche socio-culturali. Una grandissima conquista di civiltà e di crescita. Eppure è sotto gli occhi di tutti che questo indispensabile riequilibrio sia presto sfuggito a logiche razionali, viziato da influenze ideologiche e politiche, che nei massimi sistemi nascondono sempre spinte finanziarie.
Fino agli anni Ottanta, inutile confutarlo, le redini del “sistema dell’arte” erano – salvo sporadiche eccezioni – saldamente nelle mani di attori che per semplicità definiremo “occidentali” (europei, anglo-americani). Dagli anni Novanta, grazie all’azione di diversi studiosi illuminati – Harald Szeemann, Jean-Hubert Martin, per citare qualcuno – sono iniziate ad emergere istanze “periferiche”, stimoli nuovi provenienti da realtà spesso ignorate, capaci di immettere ossigeno in un contesto non di rado asfittico e tendenzialmente autoreferenziale.
Risultati contrastanti
Negli ultimi anni, tuttavia, a questo salutare “revanchismo” si va sostituendo un meccanismo uguale e contrario al vizio originario. Oggi molti segnali sembrano voler affermare una aprioristica superiorità di quanto emerga da realtà vittime del lungo oblio. Con risultati spesso contrastanti, quando non del tutto scollegati all’oggetto fulcro di ciò che definiamo come “arti visive”, ovvero la qualità intrinseca di un’opera. Paradigmatico quanto avvenuto nel 2020, quando la seguitissima Power 100 List stilata dalla rivista ArtReview pose al primo posto il movimento Black Lives Matter. E gli esempi a conferma di questo trend sarebbero infiniti.

Anche la Biennale di Venezia, che resta il più importante evento internazionale per l’arte contemporanea, pare adeguarsi ai nuovi standard. Dopo una mostra ampiamente – per molti troppo – inclusiva come quella del brasiliano Adriano Pedrosa, ora arriva la direzione della camerunense Koyo Kouoh. Nulla da eccepire, ovviamente, sulle capacità dei personaggi coinvolti, del resto avvalorate da importanti curriculum. Ma una domanda si impone: davvero gli “occidentali” hanno improvvisamente perduto ogni capacità di leggere la realtà contemporanea? Da qui avviamo un’inchiesta nella quale coinvolgeremo critici, artisti, direttori di museo, giornalisti, galleristi. Certi di proporre un approccio provocatorio, e anche divertente…
Tiziana Cera Rosco
Ci sono domande che valgono per i teorici – le cui risposte arrivano anche con la dovuta distanza temporale dal fatto, dalla situazione o dalla riflessione che le suscita perché la realtà deve essere letta mettendola a fuoco e tutto ha bisogno di tempo e spazio- e domande che valgono per gli artisti, che sono, al di là di ogni teoria, immersi in una capacita di contemporaneo che deve non tenere conto delle risposte dei primi ma dell’esigenza stessa della domanda. Faccio questa premessa proprio come risposta etica che a mio parere ogni artista dovrebbe avere verso il proprio lavoro, che altrimenti sarebbe esso stesso una risposta ad una teorizzazione sempre vecchia del mondo dell’arte e non la grande opportunità di leggere -e rileggersi- in un contesto attraverso il processo del proprio lavoro che risponde, come dicevamo, ad un’esigenza.
L’esigenza porta sempre un sovvertimento, non se ne può fare a meno, altrimenti è una vogliuzza e, come diceva Nietzsche per i vanitosi, esiste una vogliuzza per il giorno e una per la notte e questo è tutto. Un’esigenza è una forza agente senza la quale il resto sarebbe solo un discorso, nel migliore dei casi.
Il mercato, che è sempre stato la grande banca dell’arte e non l’esclusivo mondo dell’arte, negli ultimi decenni trova, mai come prima, mezzi diversi e decentrati per produrre controaltari e cosi anche correnti di esigenze artistiche che sembravano percorrere piccole rotte ai bordi del grande fiume, trovano la spinta per essere longeve e coerenti, visibili, codificate, producono stabilità e dunque trovano la possibilità di un corso parallelo a quello assodato, formando un’estetica narrativa dei loro percorsi, estetiche che stabiliscono anche un discorso sul metodo con istanze che perturabano la situazione staticizzata a cui noi siamo tanto abituati nelle fiere. E così, anche economicamente (non parliamo di un’economia di denaro ma di appello al tavolo delle presenze) queste, diciamo, nuove istanze, si inseriscono nel flusso centrale con la loro temperatura, cambiano la febbre della produzione e quindi anche una diversa possibilità di assorbimento dello stato di salute, non solo della narrazione artistica, ma anche dell’evenire artistico.
Ma anche questo è un discorso di corsi e ricorsi storici. Abbiamo tutti bisogno di un’alterità attraverso la quale rileggerci, specchiarci deformati e che ci perturbi anche con l’insignificanza, con il ritardo culturale (per quello che è il nostro orizzonte di sviluppo occidentale), con l’ingenuità o il grido che scopre parti di corpo rimaste invece inascoltate e incomplete e che rimetta in circolo la domanda sulla nostra posizione in maniera più cruda di una parola in una teoria.
Il mondo ha bisogno di muoversi, di ondulare i piani, non solo di sperimentare la profondità di una radice. Ed ecco dunque la presenza sempre più massiva della danza, del movimento, e anche il canto. Dello spostamento, dunque, della migrazione sia fisica che dei significati, dei modelli estetici. Ha bisogno di conoscenza del reale oltre l’elaborazione oltre i racconti e ecco gli artisti che vanno, come antropologi, a farsi informare dal territorio o da un popolo o solo da un modo diverso di produrre un colore che finirà poi nell’intricato tessuto di una trama. Ma se Maometto non va alla montagna? È un’intera montagna che va da Maometto. Il che vuol dire che non c’era posto per questa montagna, che per accoglierla bisogna dismettere ( e a volte le forze della vita lo fanno da sole) tutta una serie di rigidità che tenevano un vestito abbottonato su un corpo che vuole muoversi senza cerniere. Vuol dire dismettere potere, la cosa più complicata del mondo, che non può essere fatto da un giorno all’altro. Vuol dire fare posto, e qui si non solo alla potenza – vedremo – ma al potere, secondo un’emanazione consequenziale. La biennale dell’ultima edizione, ma anche della scorsa anche con più intenzionalità, ha manifestato tutta la sua democraticità: più presenza delle realtà che hanno stabilito una voce ma lontana da noi e dai nostri codici, meno narrazione nel vuoto dell’insignificanza. Non si tratta solo di quote ma di migrazione di centri di significato. E vorrei aprire un’avvia parentesi: quella delle quote, appunto. Perché siamo tutti allergici ad una par condicio che abbassa le vette in cui, senza di essa, possiamo arrivare perché la crudeltà dello sviluppo ( e ovviamente sto tenendo conto dello sviluppo di logica occidentale, nella quale mi trovo) questo prevede. Ma a volte le quote sono necessarie per permettere a tutti di esporre una voce, di averla riconosciuta e dunque di farla crescere nel confronto. Altrimenti siamo tutti votati al merito di qualcosa che per primi non potremo più prendere perché una bella bocca confezionata ad arte, costosa, ma che rimane muta, non decodifica, non parla può solo essere baciata come un morto da un morto.
Io mi aspetto qualcosa non dall’esotismo in sé ma, come scherzosamente potremmo dire, dall’esotismo in me, dall’apertura di cui sono fatta, ma dal cambio di passo e di ritmo e di realtà strategiche a cui altre culture ci obbligano facendoci entrare nel loro tempo e nel loro spazio, una catastrofe reale nelle nostre credenze, un terremoto di pazienza oggettivo. La democrazia richiede questo rivolgimento.
Oppure decidiamo che nulla è democratico ma la sovversione che si prepara per una mancata vigilanza della proprio arroganza, meriterà poi l’essere lasciati indietro nella mancanza di capacità di far crescere quest’organo: quello dell’incontro. Per ritornare al nostro discorso, penso che siamo tutti rimasti colpiti dalla parte performativa, parlo sempre della Biennale dell’ultima edizione, non immensa ma importante, di quel corpo nero che danzava come un demone nel petrolio: Joshua Serafin, filippino e multidisciplinare, col suo video della performance Void, Lo prendo come emblema perché proprio performativamente ad esempio risponde a codici molto vecchi ma l’esigenza a cui risponde è molto potente. Dunque non il potere estetico ma la potenza dell’esigenza che riformula anche un’estetica. Questo per me vale anche per il padiglione Italia, di tutt’altra ricerca: un’ultra intelligenza dell’Opera, dell’Opera in sé, spostando il piano comunicativo nell’ipercomunicazione dell’opera lasciata sola (anche se poi è stata tradita con un eccesso di apparato collaterale critico che ha ucciso la centralità dell’Opera con una produzione di linguaggio collaterale che denunciava la non fiducia nella potenza dell’opera per riprendere il potere). Due esempi che tengono in piedi la diversità dell’esibire, e oso dire anche ingenuamente ma nella totale fiducia che un gesto sia ancora comunicabile, e dell’esporre, con il prezzo del grande tradimento, questo si tutto occidentale, riguardo la fiducia nella comprensione per il lavoro costruito.
Abbiamo bisogno di fiducia nel lavoro e nel senso, per questo abbiamo bisogno di cambiare. La sfiducia nel lavoro provoca sistemi economici malati.

E da artista mi permetto di aggiungere un’ingenuità forse ossia che ho bisogno frequentare zone di senso estetico (che non vuol dire etico o narrativo) diverso dal mio: se voglio che qualcosa risuoni prima di tutto per me, come uno sparo in una derrata che non pensavo di avere nei miei possedimenti, mi devo spostare. Non importa la mia età o quanto stabile sia il mio codice nel mondo di riferimento che mi sono creata o tenendo conto del famoso orizzonte degli eventi. Imparare anche come l’arte sta al mondo. Si impara dall’allargamento dell’esperienza di cui qualcuno si fa portatore. Che sia un curatore, un teorico, un gallerista, la mancanza di visione in questo senso, capiamo quindi sempre di più, essere un danno feroce: il danno alla potenza a favore del potere è una cosa molto grave, imperdonabile. Perché il danno alla potenza simula un’esigenza, e la simulazione di questo rapporto è il posto più lontano da un accadimento artistico. Se queste parole vi sembrano astratte, chiedetevi a cosa permettete di darvi consistenza perché tutta l’economia, per non collassare come sta facendo, ne deve tenere conto: deve rispondere ad un’esigenza reale.
L’occidente se l’è raccontata con i suoi soldi e con le sue posture, ma succederà ogni volta che quel rapporto che dicevamo si perverte, riversando in un mercato illogico delle iperboli economiche fino a isterizzarle. Fino a passivizzarci con la mancanza di dignità delle vogliuzze. Ci servono queste iperboli? No. Si è raffreddata col potere la potenza. Si è abbassato il tetto in cui le cose possono potenziarci. Perché l’occidente dovrebbe avere una presa che non prende più nessun corpo ( parole ovviamente in senso metaforico)? I nostri corpi crescono e hanno bisogno di nuovi territori perché vengano espressi e di dimensioni che siano adeguate ad una sproporzione che però rispecchia un’esigenza che, con la sua reale nuova proporzione ( perché è commisurata ad un bisogno reale), può riformulare le misure dalle quale possiamo farci misurare. E’ cosi che si aumenta la realtà.
L’esigenza ha un grande potere migratorio per tornare al suo centro. Dove si inventa un bisogno, come spesso abbiamo fatto e non apro neanche il catalogo dell’intelligenza artificiale, si inventano risposte e dove si inventano risposte si inventa un linguaggio che non è in relazione con nulla che ci riguardi.
E domanda e risposta non saranno più commisurate tra loro nello sviluppo del linguaggio dell’esigenza. Questo è il male artistico.
Mauro Cuppone
“Amici, Romani, concittadini, prestatemi orecchio; vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che gli uomini fanno sopravvive loro, il bene è spesso sepolto con le loro ossa; e così sia di Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso: se così era, fu un ben grave difetto: e gravemente Cesare ne ha pagato il prezzo. Qui, col permesso di Bruto e degli altri – ché Bruto è uomo d’onore; lo sono tutti, tutti uomini d’onore – io vengo a parlare al funerale di Cesare. Fu mio amico […] ma Bruto dice che fu ambizioso; e Bruto è uomo d’onore. Molti prigionieri ha riportato a Roma, il prezzo del cui riscatto ha riempito il pubblico tesoro: sembrò questo atto ambizioso in Cesare? Quando i poveri piangevano, Cesare lacrimava: l’ambizione dovrebbe essere fatto di più rude stoffa, eppure Bruto dice che fu ambizioso; e Bruto è uomo d’onore. Tutti lo vedeste, al Lupercale tre volte gli presentai una corona di re, e lui tre volte la rifiutò: fu questo atto di ambizione? Eppure Bruto dice che fu ambizioso; e, invero, Bruto è uomo d’onore. Non parlo, no, per smentire ciò che dice Bruto, io sono qui per dire ciò che io so. Tutti lo avete amato una volta, non senza ragione: qual ragione vi trattiene dunque dal piangerlo? O senno, sei fuggito tra gli animali bruti e gli uomini hanno perduto la ragione. Scusatemi; il mio cuore giace là, nella bara, con Cesare, e devo tacere sinché non ritorni a me” (William Shakespeare, Giulio Cesare” III, 2; orazione funebre di Marco Antonio)
Amici, artisti, concittadini dell’Impero. Da artista mi è più congeniale fare domande che dare risposte (“se non ci fossero stati gli sciocchi, dovremmo esserlo noi”; William Blake, Proverbi Infernali).
L’Arte è l’orto dove si coltivano proprio i dubbi e le contraddizioni. Credo che l’arte sia nemica di ogni certezza! Gli artisti pur essendo stati sempre opportunisti, ipocriti, bugiardi (i migliori anche ignoranti e voltagabbana), hanno sviluppato e approfittato di queste qualità per sopravvivere ed esprimersi in contesti in cui non sarebbe stato loro permesso, per aggirare censure e vincoli – Giotto nella cappella degli Scrovegni, il suo committente Enrico, figlio di Rinaldo (della nota famiglia di usurai padovani che Dante mette all’Inferno), lo mette in Paradiso!
L’Arte, dal primo momento (ogni volta) che si pensa come tale, che ci piaccia o no, è ruffiana. Chi la pratica è, nella maggior parte dei casi, un “privilegiato”. In primis gli artisti e i critici che oggi provengono da mondi/generi fino ad oggi marginali e periferici rispetto alla cultura dominante occidentale. Gran parte di loro sono ricchi, hanno studiato, vivono e si sono formati in Europa o in Usa. L’anagrafe, il colore della pelle, l’opinione politica o il genere a cui appartengono sono, di per sé, una garanzia di onestà intellettuale o di appartenenza? Sono davvero rappresentativi del “terz*, quart*, quint* mond*” di cui diventano oggi i paladini? O sono semplicemente strumenti di una ennesima speculazione finanziaria (sempre occidentale – per ora) di cui sono complici e insieme comparse? Non è forse un’altra forma più raffinata di colonialismo, di “estrazione mineraria” di materie prime? Non costano meno e rendono di più, laddove conviene delocalizzare la produzione?
Ma l’unica domanda davvero (mai) definitiva che oggi dovremmo porci, per l’Arte, semmai è questa: può esistere un’arte assertiva, capace di snocciolare verità “social” da supermarket imbellettate da un po’ di militanza? Per anime belle? Non è di per sé una contraddizione in termini? Ci interessa davvero sapere se l’artista (v. le didascalie della Biennale di Pedrosa) è attivista, o peggio, under 30? Sarebbe già di per sé una attestazione di merito artistico? Se, in privato, appartenesse alla Croce Rossa o al Ku Klux Klan, artisticamente parlando, cambierebbe il risultato? Questo nuovo pensiero unico, superficialmente e falsamente inclusivo, conseguenza inevitabile del politically correct che ci ha travolto, non ci sta portando inevitabilmente alla “vera” e definitiva morte dell’Arte? Scusatemi, il mio cuore giace là, nella bara, con Cesare, e ora devo tacere sinché non ritorni a me.

Roberto Floreani
Penso che la dominante di qualsiasi discorso dedicato all’arte contemporanea non possa prescindere – volente o nolente – dallo strapotere del mercato. Viene citata la Biennale di Pedrosa come un esempio di focalizzazione sugli “altri”, ma così non è stato: qualsiasi rassegna che voglia promuovere veramente un ambito con una selezione superiore ai 10-20 artisti, in realtà diventa “La Biennale di Pedrosa” e non degli artisti, persi in un anonimato diffuso. Ad oggi nessuno ricorda più di qualche nome tra gli oltre 300 selezionati e non certo tra le proposte inedite, cosa apparsa evidente fin dall’inizio. Quanto alla nuova curatrice Koyo Kouoh direi di aspettare correttamente quel che avrà da dire: per il momento ha tutte le carte in regola per essere l’ennesima proposta dal solito versante politicamente corretto. Ma aspettiamo, senza patemi e, ahimè, senza alcuna urgenza. I tentativi d’imporre una nuova scena per ora sono estremamente goffi, infatti credo non basti catapultare sconosciuti a valutazioni milionarie per il semplice fatto di rappresentare soggetti con la pelle scura, come sta avvenendo nelle aste americane. La globalizzazione ha riguardato anche l’arte e in senso deteriore, per cui si assiste all’affermazione di artisti con origini decentrate rispetto al sistema, ma che da decenni studiano a Londra o negli States, riproponendo di fatto la medesima temperatura degli autoctoni. Quanto alle opere, la quasi totalità delle “novità” extraterritoriali occhieggia in modo spudorato alle tematiche care all’occidente, che non dovrebbero essere le stesse a latitudini diverse, autenticamente realizzate con l’urgenza della denuncia. Oggi sembra che una crisi d’identità riguardi la comunità mondiale, più che una parte di essa.
Trovo straordinariamente romantico disquisire sulle varie modalità delle proposte o sulla salute dell’Arte, quando si assiste ormai regolarmente a operazioni gestite a tavolino tra colpi di teatro e criptovalute. Bene così, nessun moralismo d’accatto, ma basta chiamare le cose col loro nome. Quanto alla crisi, se il “sistema” non riguarda solo pochi privilegiati, al mondo esistono decine di migliaia di artisti affermati che lavorano, espongono, vendono, vivono, propongono, dichiarano, senza dipendere esclusivamente dalla roulette delle aste, cioè la stragrande maggioranza del sistema reale e tuttavia non sono di fatto inseriti nella dorata dicitura di Arte Contemporanea, diventata una griffe per artisti disciplinati. Quanto all’attualità così agognata e apparentemente indispensabile, sfogliando i libri di tutti i tempi sono gl’inattuali che hanno indicato la via in pressochè tutte le discipline.
Talmente calzante all’argomento che vale sempre ricordare il saggio Il Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler completato nel 1914, passato di moda dopo un successo planetario, ma che riporta, nelle oltre 600 pagine, passaggi autenticamente profetici rispetto a quel che sta accadendo oggi, valutando anche che, da allora, l’occidente si è concesso il lusso di due guerre mondiali e mezzo e una quarantina d’anni di Guerra Fredda che hanno devastato mezzo mondo. Basta molto meno per perdere identità.
Ma le leggi del mercato mondiale votate al profitto superano la politica e l’occidente non solo non ha perso la presa – quella vera – ma controlla mercati con valori di partenza irrisori e quindi con potenziali margini di guadagno enormi, ricorrendo alle medesime stategie pilotate dalla comunicazione globale e adottate fino ad oggi per ottenere un consenso generalizzato. L’occidente detiene i mezzi e i luoghi dove decide per sé e per gli altri: sarà Art Basel ad andare in Africa e non viceversa.
Basterebbe riflettere sulla lezione della storia che ha visto i precursori – umanamente inascoltati, viste le intuizioni in anticipo sul loro tempo – uscire di senno o morire di fame. Oggi, per miracolo, gli artisti d’avanguardia (quelli dell’”arte contemporanea”) pare sfornino solo capolavori milionari in un’improponibile, ammiccante avanguardia di consenso, perfettamente sincronizzata con il suo tempo, parlando la stessa lingua del mainstream, usando gli stessi vocaboli, trattando rigorosamente argomenti à la page. Il Romanticismo finisce con le guerre mondiali, i suoi lacerti proseguono fino alla fine del Novecento, poi arriva l’industriale della comunicazione globale Charles Saatchi che inaugura il conflitto d’interessi perfetto, il cerchio chiuso: selezione a tappeto da dentro-o-fuori, identità anglosassone, comunicazione globale (il suo mestiere), gallerie, case d’asta, museo: tutti nelle stesse mani e tutti dedicati alla stessa scuderia. Sarà l’apripista dei magnati del lusso e della finanza, dove il romanticismo delle considerazioni sulla qualità appare non funzionale, semplicemente inutile. Il prezzo sul valore, la solita storia, preconizzata fin dall’uscita della Società dello spettacolo di Guy Debord, nel lontano ’67.
Ma, seppur facendo un mestiere diverso – o almeno così pare – si può comunque continuare a parlare d’arte e a fare arte (o almeno provarci) e non di economia o finanza.