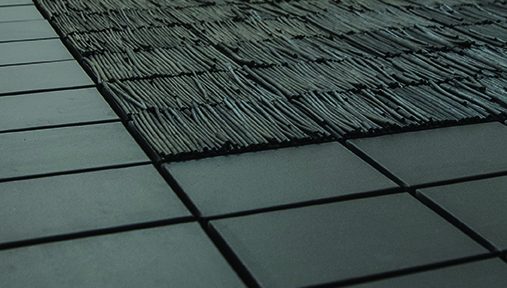Cosa s’intende per scultura oggi? Questa nuova rubrica prova a rispondere attraverso le voci di alcuni tra i più interessanti artisti italiani. A raccontarci la sua, in questa sesta puntata, è Jago.
Se c’è un artista tecnologico, questo è Jago. Se c’è un artista che ancora crede nella manualità della scultura, è ancora lui. Il suo lavoro è un singolare crocevia in cui convergono l’innovazione più spinta – almeno per quanto concerne la comunicazione, che per l’artista fa parte dell’opera – e la tradizione più antica e rigorosa.
C’è posto per un solo Jago? Non ti manca un antagonista, un artista contemporaneo che ti piacerebbe superare?
Io vivo in questa condizione: non posso non innamorarmi di tutto quello che mi circonda. Non ragiono in termini di antagonismo e non penso di essere in gara con nessuno. Sono così concentrato su ciò che faccio che mi manca proprio il tempo di constatare se ho fatto qualcosa in meno o in più di qualcun altro o a che livello mi colloco. Credo che umiltà sia consapevolezza di ciò che si è, e di cosa si vuole raggiungere: “voglio arrivare lì, ma adesso sono qui”. La grandezza che si manifesta nell’essere umano attraverso l’espressione artistica per me è una cosa magnifica; perciò, anziché provare invidia, spero sempre ci siano accanto a me persone in grado di tradurre la realtà in modi a me preclusi, che non conosco. Gli altri sono i miei occhi: la diversità degli altri è l’opportunità che ho di arricchirmi.
Quindi la mia impressione – Jago gioca da solo – è corretta. Non parlavo di antagonismo nel senso della sopraffazione e della lotta, ma in quello, credo a te non estraneo, dell’atletismo e del confronto.
Dunque dovrei chiedermi: come sto lavorando, chi sono i miei interlocutori, condivido il mio mercato con altri. Ma questi ragionamenti sono molto lontani dal mio modo di operare. Non partecipo al sistema dell’arte che conta, quello dei grandi numeri e dei riconoscimenti.

I numeri a dire il vero ci sono: la tua ultima mostra a Roma ha fatto più di centomila visitatori, e hai ottocentomila follower su Instagram – poco meno di Damien Hirst, molto più di Jeff Koons.
Quei numeri rappresentano i seguaci degli artisti, non delle opere, e significano tutto e niente. Il numero non è nulla più che un numero. E oggi i follower si possono anche comprare.
Non credo sia il tuo caso! E comunque, non temi che il branding, il marchio di fabbrica valga più dei tuoi lavori?
Quando ho iniziato a usarli, diciassette anni fa, i social erano appena nati. Io stavo da solo, su un’isola, in Grecia, e non avevo nessuno che mi rappresentasse o che fosse interessato a farlo. Dietro di me, mentre pulivo i cessi in un ristorante in cui lavoravo in cambio di pranzo e cena, c’era il proprietario del locale che chattava su Facebook, e mi disse che lì, in quel social, si trovava una galleria in cui era possibile pubblicare le proprie immagini. “Se posto le immagini delle mie opere”, pensai, “è una figata, mi rappresento da solo”. Mi resi subito conto che utilizzare Facebook mi dava una marcia in più. Con uno smartphone potevo raccontare l’unica parte che a me veramente piace della realizzazione di un’opera: il farla. Puoi condividere una foto e aspettare passivamente le reazioni degli altri. Ma il creare, il viaggio, il percorso, è sempre lasciato all’immaginazione dell’altro, non viene raccontato. Cosa facessero i maestri del passato mentre dipingevano o scolpivano possiamo solo ipotizzarlo. Di solito romanziamo, amplifichiamo, rendiamo praticamente inaccessibile la facoltà di calarsi nella loro officina, come se i “geni” fossero capaci di finire un capolavoro in una notte; e non è vero niente! Perciò ritualmente, con costanza, ho iniziato a registrami. Per me il video non è un brand: esprime una mia necessità espressiva. Che tiene, ovviamente, conto del modo in cui gli altri amano fruire un certo contenuto. Se vuoi comunicare, devi prima sapere ascoltare. Ti devi chiedere chi c’è dall’altra parte, e che lingua parla. Questi ragionamenti li ho dovuti fare negli anni per condividere il piacere che provavo, e che provo, nel creare.

Potremmo dire che il video stesso è l’opera.
Sì lo è. Il fare e il comunicare sono una cosa sola. Non c’è l’opera, e poi il brand, il pensiero strategico. Funziona tutto insieme e nello stesso tempo. L’opera non è scollegata dalla sua presentazione: è la sua presentazione. È quanto io ho fatto per concluderla, per portarla alla luce, dall’inizio alla fine.
Tra l’altro quasi nessuno oggi ha idea di quale sia il linguaggio della scultura. Da questo punto di vista, il tuo impegno nella divulgazione è da lodare.
È un impegno che non mi costa nulla: mi viene naturale. Oltre tutto mi sono accorto di come il mio imparare facendo sia diventato un meccanismo di incoraggiamento per una generazione di giovani che magari in principio non pensavano che l’arte rientrasse nei loro interessi ma che, seguendo i miei video, si sono appassionati. Quando viene da te un genitore e ti confessa che suo figlio, che ha sei anni, vuole fare il mestiere che fa Jago, per me è un goal infinito, una gioia indescrivibile. Accompagnata, ovviamente, da un grande senso di responsabilità.
A grandi poteri, grandi responsabilità. E maltrattamenti, soprusi. Hai idea del perché i vandali si accaniscono sulle tue sculture?
Per me tutto quello che accade è interessante. Quando finisco un’opera, il senso di attaccamento se ne va insieme a lei. Da un lato penso che dietro certi comportamenti ci sia la curiosità: l’atteggiamento tipico del bambino, che deve rompere per capire. In alcuni, come me, questa modalità di azione si prolunga nel tempo. E comunque, quando bussi su un tavolo, non sempre il tuo scopo è farlo a pezzi. Altre volte non sei solo, e la curiosità, eccitata dallo stare in gruppo, diventa goliardia. D’altra parte, un atto vandalico può benissimo essere una critica, o un tentativo di strumentalizzazione di un simbolo per dire qualcosa di nuovo.
Gli ecologisti che imbrattano le tele, ad esempio, le usano per far passare il messaggio che l’ambiente va difeso.
Sì, ma il più delle volte si parla soprattutto del loro gesto, mentre il messaggio che intendevano veicolare rimane in secondo piano. A questa gente vorrei dire: “Mettiamoci d’accordo. Sono disposto a darvi anch’io una mano. Volete comunicare? Siate creativi, cercate una forma originale”.
E agli scultori che non realizzano personalmente le loro opere, che cosa diresti?
Se guardiamo alla storia dell’arte, ci sono esempi magnifici di scultori della tradizione, che hanno reso noi italiani orgogliosi nel mondo, come Bernini, Canova, lo stesso Michelangelo, che non lavoravano da soli. Bernini aveva una squadra, ereditata dal padre, di almeno centro operai. Canova ha inventato lui i multipli, la produzione in serie. Il suo museo a Possagno è stato aperto proprio per preservare i modelli, una volta scomparso l’artista, da una replicazione massiva. Qual è dunque la differenza tra questi maestri e i contemporanei che si fanno fare da altri le sculture? La differenza è che Bernini, Canova, Michelangelo sapevano scolpire. Il presupposto di ogni delega è infatti la competenza totale di chi delega: la sua capacità di vigilare e, nel caso, correggere, i lavori affidati a mani altrui. Oggi l’artista ha l’idea e basta: l’esperienza del fare non gli interessa affatto. Il che, intendiamoci, è perfettamente lecito. Non sta scritto da nessuna parte che non ci si debba servire di un aiuto per mettere in pratica ciò che ci passa per la testa. Io però non potrei mai. Significherebbe rinunciare al piacere del fare. E fare vuol dire pensare.
Domina ciò che vuoi dire, dicevano i latini, e le parole verranno da sole.
Per lanciare Microsoft o Google, devi anzitutto essere un buon programmatore. In ambito artistico abbiamo forse esagerato con la preminenza assoluta dell’idea. Speriamo che questo concetto non arrivi pure alla medicina: saremmo rovinati.

Non credi che la colpa sia pure della scuola’?
Le scuole di oggi insegnano che l’idea è tutto. E va bene. Ma dovrebbero soprattutto insegnare ad essere autonomi, indipendenti. Conosco ragazzi che escono dall’Accademia convinti di essere dei grandi e all’improvviso si rendono conto di non avere i soldi per pagare chi metta in pratica le loro intuizioni, visto che non sono in grado di farlo da soli. Purtroppo queste cose le capiscono tardi, all’altra scuola: quella della vita. E allora che fanno? La cosa più semplice. Fanno i pittori. Comprano gli acquerelli, un foglio, cercano di venderli e il loro cammino ricomincia d’accapo. Avendo mani e cervello, non sarebbe il caso di utilizzarli entrambi, e in egual misura?
Perciò hai lasciato l’Accademia, senza finire gli studi?
Ho lasciato l’Accademia perché non avevo i soldi per continuare. Quindi son dovuto diventare imprenditore: ero profondamente innamorato della mia libertà e ho investito su me stesso per trasformare la mia passione in un impegno che potesse diventare anche risorsa per gli altri, a cominciare dalla mia famiglia. Ringrazio la vita per tutte le occasioni che mi ha offerto, e di cui ho approfittato. Se vuoi diventare milionario, frequenti milionari, non elemosini spiccioli dai tuoi genitori. La vera ricchezza è la conoscenza, la cultura. Col senno di poi, lasciare l’Accademia è stata una fortuna. Questa però non deve diventare una licenza di uccidere. In molti mi scrivono di voler seguire il mio esempio, ma non è assolutamente detto che ciò che è andato bene per me vada bene anche per gli altri.
Potresti averli sulla coscienza!
Dico loro: stai con un piede dentro, e un altro fuori. Serviti di tutte le risorse che l’Accademia ti offre ricordando che ogni esame non serve a conquistare un pezzo di carta, ma a costruire il tuo portfolio. Ci sono ragazzini che ogni giorno percorrono chilometri per raccogliere un po’ d’acqua. Chi può studiare è un privilegiato: guai a dimenticarlo.
Forse il privilegio più grande è il sapere che il presente deriva dal passato, dalla fatica di chi ci ha preceduto. È questo il motivo per cui sei solito scegliere soggetti tradizionali, come se la scultura si fosse fermata migliaia di anni fa?
Andrea, non guardo alle opere del “passato” come a oggetti che hanno esaurito il loro potenziale, la loro capacità espressiva. Siamo noi a decidere il nostro destino. Se Jago oggi sceglie di parlare una lingua che non reputa morta e ha abbastanza forza per imporla, questa sarà la lingua del futuro. Chi l’ha detto che, ricevendo un’eredità, dobbiamo per forza convertirla in qualcosa di nuovo? Possiamo fare un passo indietro per farne dieci avanti.

Dobbiamo quindi farci contemporanei del passato e del futuro.
La parola “contemporaneo” è strumentalizzata: è stata trasformata nel sinonimo di una tendenza, la corrente del contemporaneo. Da allora in poi il passato sembra aver perso la parola, ma così non è. Il David di Michelangelo, la Gioconda parlano ancora. Come si spiegherebbero altrimenti i turisti che si azzuffano, o fanno pazientemente la fila ore e ore, per uno sguardo, una fotografia? Evidentemente quelle opere qualcosa da dire la hanno ancora. La contemporaneità è tutto ciò che esiste e si manifesta davanti a noi qui e ora. Sfido chiunque a dimostrarmi che ciò che affermo non è vero.
Un’ultima domanda sulla “contemporaneità”. A cosa ti stai dedicando, a cosa ti dedicherai?
A te [ride].
Lo dico sempre a mia moglie quando sono fuori e mi chiama al telefono chiedendo cosa stia facendo: “sto parlando con te”.
Sto finendo un’opera, Narciso, di cui ho pubblicato un primo video. Il resto si scoprirà quando pubblicherò la seconda parte. Ho poi terminato un’altra scultura, Aiace e Cassandra, che sarà visitabile presso Sant’Aspreno, il mio studio napoletano, che presto diventerà un museo. Attualmente ci stiamo occupando della ristrutturazione e organizzazione degli spazi, compreso l’ambiente in cui è esposta un’altra mia opera, il Figlio velato, che si trova sempre a Napoli presso il Rione Sanità. Dovrò infine iniziare il mio David. Seguo tanti progetti contemporaneamente e se non mi avessi fatto tutte queste domande sarei molto più avanti.
Bene!
Scherzo, ovviamente. Rispondere mi incoraggia, mi dona nuove energie. Dovrebbe essere sempre così.