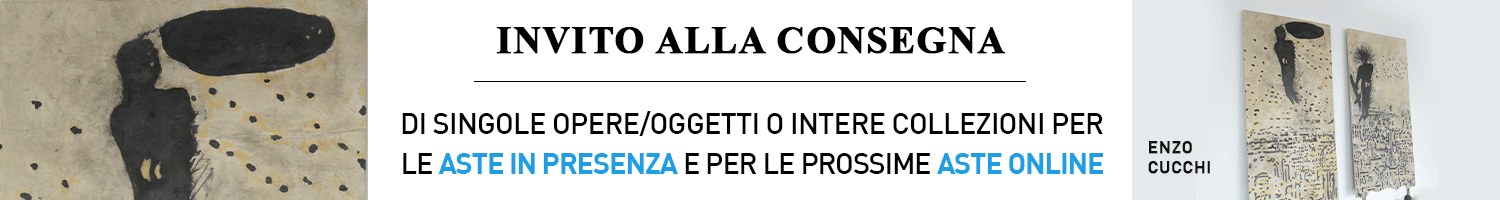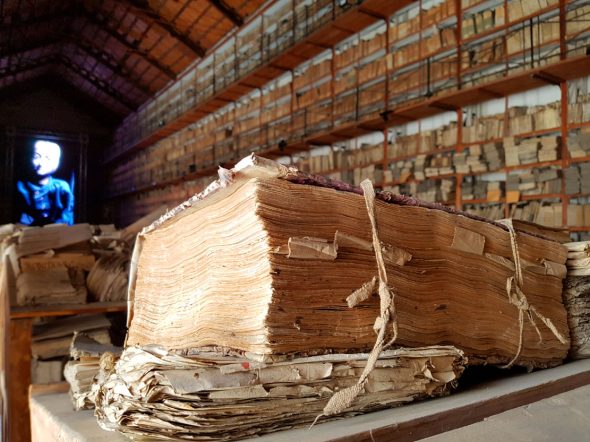
Palermo. Ci voleva l’olandesità della curatrice e storica fondatrice di Manifesta, Hedwig Fijen, per riattivare un tessuto sociale già da qualche anno brulicante e impaziente di mettersi alla prova, bisognoso di legittimità e occasioni. E riscatto. Rivincita, da mani e maglie criminali che da tempo immemore imbrigliavano il ribollio fecondo di una “cultura” diffusa ormai matura per emergere. Per mettersi in mostra, letteralmente e meno. Capitale Italiana della Cultura, Manifesta 12: una dopo l’altra sono calate come manne del cielo per dare una scossa all’atavica procrastinazione (il centro storico, per esempio, non è mai stato veramente ricostruito dopo la guerra…) e rassegnazione che serpeggia (ancora, o peggio, rema contro, vedi quelli che “con tutti i problemi che ci sono, buttiamo i soldi nell’arte”) tra mandamenti e cantoni. Due occasioni con strascico felice di migliaia di annessi, connessi e collaterali, dalla Biennale Internazionale di Arte Sacra alla Festa della Musica Europea. Palermo scelta ideale. Metafora tracotante di contraddizioni. In bilico nel suo trascorso secolare, di glorie come di vergogne, lapidi e fiori in giro per la città lo testimoniano, tra Inquisizioni ormai sepolte e mafie ancora accese. Una città infinita in balia di se stessa, assorta nei toni morbidi della panna e dell’ocra, sensuale, costellata dalle mille sfumature di verde -di palme, fichi, ficus e rampicanti vari- pregna di odori, satura di profumi, dalla frutta ai fritti. Porta tra nord e sud, crocevia di genti e di ben tre continenti. Più uno: quello liquido del Mediterraneo, luogo simbolo di scambi e osmosi di civiltà, ora ridotto a muro e morte. Palermo, figlia consapevole (e orgogliosa) di un’identità aperta e meticcia, che la rassegna -prepotentemente politica, e quindi impegnata- ribadisce e riverbera in maniera tanto assordante (in senso positivo, perché così va fatto) quanto purtroppo didascalica, troppo spesso povera dal punto di vista poetico formale (ci ritorneremo fra poco). Un microcosmo -che vuole essere macro, esempio per tutto il mondo- nel quale vige un riconosciuto e stupefacente sincretismo estetico e culturale, prodotto di tradizioni, culture e culti. A proposito, dopo ben 500 anni riapre la Sinagoga in un oratorio cattolico a pochi passi dalla Moschea. In un quartiere, quello ebraico, dove le vie sono scritte in arabo, ebraico e italiano, che piano piano si sta riattivando, sulla scia del quasi completamente rivitalizzato quartiere arabo, la Kalsa, centro pulsante di Manifesta (vedi il nuovo corso del Teatro Garibaldi fino a qualche tempo fa una discarica a cavea aperta). Dove anche l’arte urbana comincia a passare a setaccio le pareti scrostate e abbandonate portando valore.
Un solo mantra: assorbire e rigenerare. Perché, parafrasando Rasheed Araeen: solo quando le persone sono in grado di utilizzare le proprie potenzialità creative, potenzialità che possono essere valorizzate da un’immaginazione artistica, si verificherà il cambiamento. Ce lo ricorda bene anche la Fijen. L’arte può e dovrebbe sforzarsi di proporre un’alternativa che non si riduca a un’affermazione estetica, ma che sia realmente benefica per tutte le forme di vita. Creare alternative attraverso l’arte. Creare conoscenza critica per una crescita civile, per emergere dal torpore, per emanciparsi dai mostri dell’ultimo secolo. Perchè come ci viene incontro passeggiando verso la Vucciria una frase di Erich Fromm dipinta su una delle botteghe artigiane che popolano il centro storico (facendo fitta e feconda rete tra loro): “L’uomo che non può creare vuole distruggere“. I semi ci sono, Manifesta lo constata e lo prova. Ora, su queste basi, si deve proseguire e perseverare, perché si può e si deve fare di più. Crescere e implementare, portata, offerta e qualità. Come sopracitato, infatti, molte opere sono descrittive al limite del documentaristico, materiale già visto per quanto meravigliosamente assemblato e proposto. Potente ed efficace certo -dati i temi su cui verte il tutto, come immigrazione, accoglienza, sfruttamento, traffico di uomini, cambiamenti climatici, diritti umani, crisi globali- ma sul piano prettamente artistico risultano spesso espressioni deboli (fanno eccezionale eccezione per esempio gli ultracelebrati e fotografati lavori dei Masbedo e dei “collaterali” Massimo Bartolini e Per Barclay). Più cronaca che contemplazione. La maggior parte dei progetti, poi, non è -com’era prevedibile- all’altezza dei luoghi, dai palazzi alla natura. Basti vedere che fine fanno le installazioni all’orto botanico dei nostri contemporanei schiacciati dai ficus magnolioide o affogati tra le ninfee negli stagni. O la gran parte delle opere (regna l’installazione, il video, la fotografia; quasi nullo lo spazio a pittura e scultura) perse nei trionfi barocchi, negli stucchi mirabili di Serpotta e in generale inghiottita nella storia delle strutture “ricettive”. Il contesto è manifesto e dominante da questo punto di vista, ma il “contesto” -ossia, citando in senso lato Montanari di “quell’inestricabile groviglio di paesaggio e arte, memoria e storia, bellezza e conoscenza che dà senso al rapporto tra presente, passato e futuro”- è rispettato e valorizzato. Per esempio coinvolgendo e facendo interagire artisti e architetti con cittadini, professionisti (da botanici a geografi e antropologi), organizzazioni no-profit e associazioni locali per immaginare e progettare usi diversi dello spazio pubblico. Ricordiamo che la ricerca preliminare della manifestazione è stata affidata allo studio olandese (e internazionale) di architettura OMA, in modo da far nascere prospettive e soluzioni per il futuro della città grazie all’analisi di ciò che nella città è già presente e che già opera per il suo cambiamento.
Finalmente una biennale (tralasciando la cadenza temporale, chiamasi biennali questi ormai effimeri happening mondani che nascono come funghi da tutte le parti del mondo) non autoreferenziale, come quasi tutte le kermesse fieristiche ed espositive che spopolano nel circo del mondo dell’arte. Vedi alla voce: vuoto edonismo. Quei caroselli glamour, modaioli e patinati che come ci ricorda Vargas Llosa accolgono “molta più frode e imbroglio che serietà, che profondità”, rivelando “la terribile orfanità di idee, di cultura, di abilità artigianale, di autenticità e di integrità che caratterizza buona parte dell’attività artistica di oggi”. Ossia: il degrado del “contemporaneo”. Al contrario, fortunatamente, la nostra nomade biennale ha sincera sostanza e si rivela una manifestazione se mai positivamente ingenua. Non elitaria. Anzi: umile, non figlia (la maggior parte dei lavori almeno) di tristi performance e derive radical chic, e priva di quell’imbarazzante e fastidioso meta linguaggio pseudo concettuale e filosofico che caratterizza gli spettacoli modaioli e consumistici delle varie Venezia e Kassel sparse per il mondo. Questa Manifesta, il cui linguaggio è davvero alla portata di tutti, ha poco da spartire con esse. E la preferiamo di gran lunga così, aperta e piacevolmente informale, anche con orari che vanno e vengono, con indicazioni a metà, con palazzi che sono ancora per metà cantieri, con un’organizzazione non puntualissima. Questa è anche Palermo. Tutto fa parte del gioco, c’è poco da incazzarsi se non si trova subito il palazzo in questione evidenziato sulla mappa. O meglio, bisogna farlo sì, ma per le cose serie che stanno in altri Palazzi (quello dei Normanni per non andare lontano). Ora, non sappiamo se possa essere davvero una nuova alba per la città, e da qui la luce rosea propagarsi per il paese intero. Potrebbe (forse utopisticamente) essere una possibile risposta prepotentemente colta e profonda alle grette derive italiche di cui vediamo ora la più deprecabile apoteosi. Stando coi piedi, oltreché ai semi, piantati per terra, diciamo che un granello di quell’ibrido Giardino Planetario -da cui tutta Manifesta Palermo nasce e cresce- è stato posto. Un seme all’alba. Di un’alba riflessa sul mare, vista Marsiglia, altro hub del Mediterraneo che accoglierà Manifesta 13 nel 2020. Una impollinazione incrociata che ci dà qualche flebile speranza.